Salvatore Paolo Garufi Tanteri; DALLA “NATIVITA’” DI ANDREA DELLA ROBBIA AI “CONTADINI” DI SANTO MARINO – Storia dell’arte a Militello nel Valle di Catania –
12 Settembre 2019da salvogarufiFACEBOOKTWITTERPINTEREST
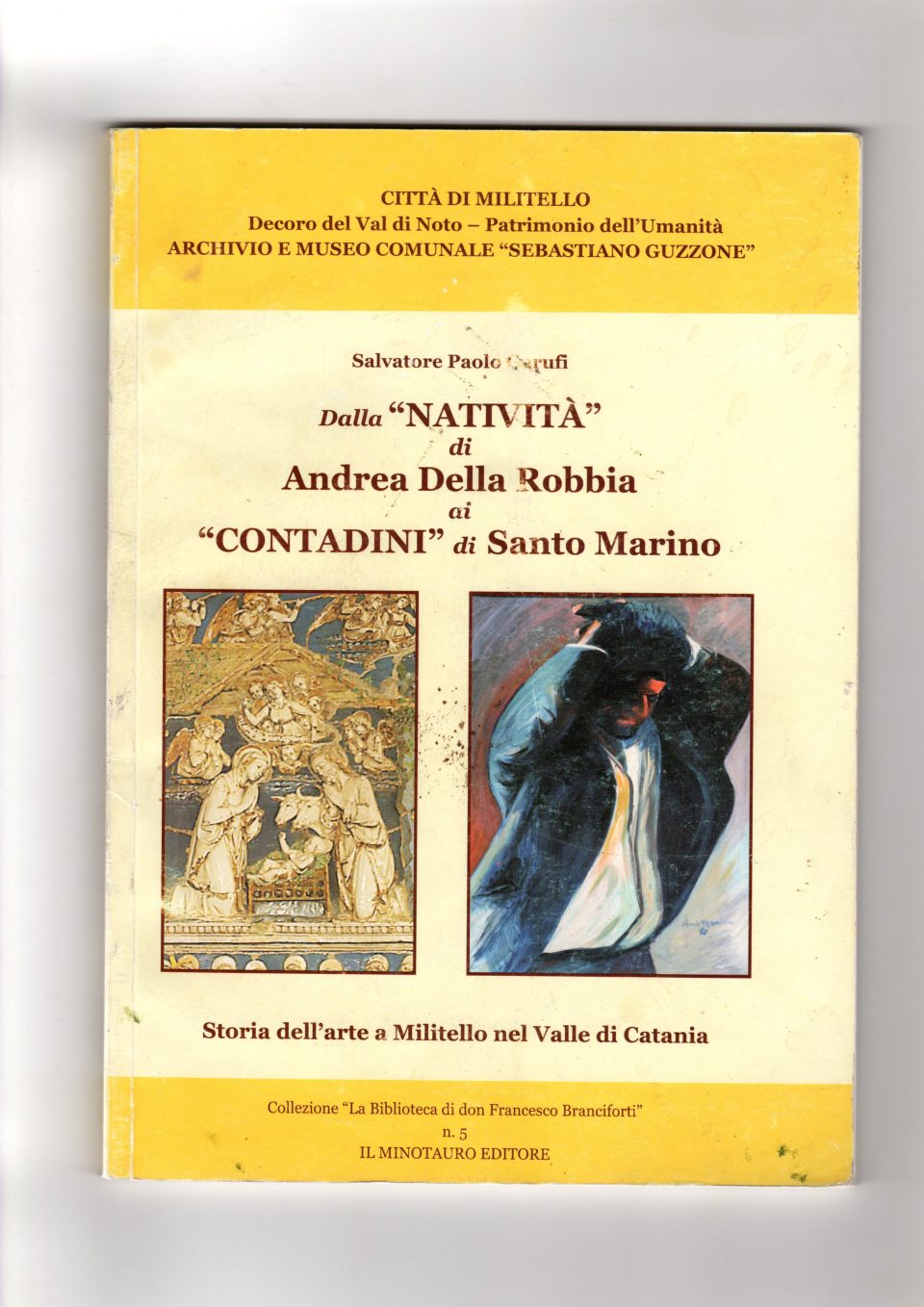
CITTA’ DI MILITELLO
Decoro del Val di Noto – Patrimonio dell’Umanità
ARCHIVIO E MUSEO COMUNALE “SEBASTIANO GUZZONE”
SALVATORE PAOLO GARUFI TANTERI
DALLA “NATIVITA’” DI ANDREA DELLA ROBBIA AI “CONTADINI” DI SANTO MARINO
– Storia dell’arte a Militello nel Valle di Catania –
Collezione “La Biblioteca di don Francesco Branciforti”
n. 5
IL MINOTAURO EDITORE
I
LA PREISTORIA DI MILITELLO
1. Stili decorativi dei manufatti trovati nell’agro di Militello.
Per avere consistenti espressioni artistiche nelle vicinanze di Catania bisogna aspettare il neolitico medio (3.000 a.C.), quando si affermò la cultura di Stentinello (villaggio nei pressi di Siracusa). La sua ceramica è riconoscibile per le decorazioni impresse. Con esse si suggeriva e si esaltava la forma del vaso (in un certo senso, era come se con la decorazione venisse definito l’oggetto, sottolineandone una sorta di forma assoluta).
Probabilmente erano presenti espressioni non spregevoli di tale cultura in contrada Oxena (Tra Lentini e Militello), stando ai reperti ceramici riconoscibili per le decorazioni impresse, provenienti da corredi funerari.
Infatti, momento importantissimo della cultura di Stentinello fu il culto dei morti. Con essa i cadaveri vennero inumati individualmente nella cosiddetta cista litica, un recipiente a forma di scatola seppellito nel terreno ed, in genere, delimitato da ciottoli e pietre. Questo particolare mette in diretta connessione la cultura di Stentinello con la greca civiltà micenea, dove:
“Per quanto riguarda le forme architettoniche funerarie dobbiamo innanzitutto ricordare la più antica e diffusa: la tomba a cista, una fossa quadrangolare foderata con lastroni di pietra, in cui erano inumati più individui in posizione ranicchiata. In seguito le sepolture si presentano come fosse allungate che accolgono i defunti in posizione supina.”(1)
Per il periodo successivo, va ricordato un vasetto anch’esso trovato ad Oxena e citato da Bernabò Brea, oggi nel Museo “Paolo Orsi” di Siracusa. Il manufatto è decorato e graffito dopo la cottura e presenta analogie con la ceramica dello stile di Piano Notaro (prima del 1.800 a.C., nell’età eneolitica).
Ma, le prime, consistenti testimonianze archeologiche nel territorio di Militello si trovano a partire dall’età del Rame. Infatti, appartengono a quest’epoca i resti di “alcune capanne delimitate da stretti fossati ed una tomba a pozzetto”, individuati in contrada dosso Tamburaro(2).
Più recentemente, inoltre, resti simili sono stati trovati in contrada Fildidonna, su un pianoro prospiciente dosso Tamburaro. La morte, però, è riuscita ad attraversare meglio i secoli, se si pensa che in contrada Annunziata possiamo ammirare alcune tombe della cultura di Castelluccio (tra il 1.800 ed il 1.400 a.C., nell’età del bronzo antico). Così, sparse nel contado di Militello si trovano diverse necropoli di quel periodo. Nel pianoro di Santa Barbara, per esempio; oppure nella collinetta di fronte alla contrada di San Vito, dove le grotte per sepolture probabilmente appartengono all’età del bronzo.
Paolo Orsi chiama tale cultura “primo periodo siculo” e Luigi Bernabò Brea esclude che i suoi portatori fossero dei siculi. La cultura dei siculi, invece, è rappresentata a Pantalica ed appartiene all’età del bronzo recente (1.250 a.C.) La cultura di Castelluccio, infatti, non ebbe alcuna affinità con quella dell’Italia peninsulare, da cui provenivano i siculi. Contiene, piuttosto, elementi greco-anatolici e, quindi, indica un’origine orientale. Essa si estese nella parte sud-occidentale e meridionale dell’isola. Tutto sommato fu una cultura unitaria, anche se in base alla decorazione ceramica possiamo distinguervi due diverse “facies”.
Le tombe furono scavate nella roccia calcarea, secondo una forma ovale, raramente raggiungendo, o superando, i due metri. Le piccole porte d’ingresso (al di sotto del metro, tra i 70 ed i 90 cm.) venivano chiuse con murature a secco, o con portelli di pietra, che potevano essere decorati a rilievo, con motivi spiraliformi (ed a tal proposito è interessante sapere che Bernabò Brea notò la vaga analogia che questi portelli presentano con le sculture dei templi maltesi dell’età di Taxien, anche se queste sono artisticamente superiori e cronologicamente più antiche).
Vi si trova una ceramica, che si caratterizza per le linee nerastre su fondo giallino o rossastro (qualche volta è possibile trovare ritocchi biancastri). Le forme ed i motivi si ripetono: grandi anfore biansate, vasetti gemini a saliera e così via.
La forma più comune nel territorio di Militello è il vasetto trilobato e monoansato, oltre alle ciotole più o meno povere. Vi troviamo, comunque, tracce di un periodo in cui la civiltà mediterranea si espandette politicamente ed economicamente, giungendo a contatto con paesi lontanissimi. Con la mediazione della Francia e della penisola iberica, infatti, questa civiltà arrivò fin verso le isole della Gran Bretagna, poiché dalla Cornovaglia veniva lo stagno per ottenere il bronzo.
Note
- Gillo Dorfles-Cristina Longhi-Chiara Maggioni-Maria Grazia Recanati, Arti visive, vol. I, Atlas, Bergamo, 2000, p. 52;
- Maria Grazia Branciforti, Il riposo del guerriero, in Militello in Val di Catania, suppl. al n. 6 di “Kalos”, Edizioni Ariete, Palermo, Novembre-dicembre 1996, p. 2.
2. Catalfaro araba.
L’ivasione araba cominciò a metà di luglio dell’827, l’anno 6335 del calendario greco (dal 1 settembre 826 al 31 agosto 827), come usavano datare gli storici arabi (quando volevano riferirsi al calendario dei “Rum”, cioè dei bizantini).
Arrivò una truppa che (ovviamente, oltre agli arabi) comprendeva berberi della Tunisia, musulmani, spagnoli e forse anche negri sudanesi(1).
Lo sbarco avvenne a Mazzara; poi, la guerra tra cristiani e islamici seguì un percorso di avvicinamento di quest’ultimi verso la capitale, Siracusa. Nell’830/831 (cioè nel 6339 del calendario greco) arrivarono dalle parti di Militello, conquistando Mineo, da loro chiamata Minawh.
Poi, nell’831/832 (6340 greco) fu presa Palermo, nell’841/842 (6350) vi fu una terribile invasione di cavallette, nell’844/845 (6353) caddero le rocche di Modica (Mudiqah per gli arabi) e nell’846/847 (6355), con la caduta di Lentini, ovvero L.tayanih, tutto il territorio all’intorno era ormai islamizzato(2).
Nell’878 gli arabi saccheggiarono Siracusa e facilmente qualche eco arrivò nell’attuale territorio militellese, magari in termini di profughi, dato che la sorte degli sconfitti fu terribile. Moltissimi prigionieri vennero uccisi e l’arcivescovo fu risparmiato soltanto perché svelò dove si trovava il tesoro della cattedrale.
Quando l’opera della soldataglia finì, “si disse che non era rimasta anima viva in una città che una volta era stata rivale di Atene e di Alessandria e che superava di gran lunga la Roma contemporanea in ricchezza e splendore”(3).
L’ultimo importante avamposto cristiano, quello di Taormina, cadde nel 902 e, infine, l’ultimo focolaio di resistenza organizzata, quello di Rometta, fu spento nel 965.
I tempi della dominazione musulmanna videro in questo territorio il fiorire del sito di Catalfaro. Esso venne citato dal geografo ‘Abu ‘Abd ‘Allah Muhammad ‘ibn Muhammad ‘ibn Abd Allah ‘ibn ‘Idris, che gli occidentali hanno chiamato Edrisi, nel suo Kitab nuzhat ‘al mustaq…, ovvero Libro del sollazzo per chi si diletta di girare il mondo.
Eccone le parole esatte:
“Da Lentini alla Qal’at Minau (comune di Mineo), per ponente a mezzogiorno, ventiquattro miglia. Mineo, bella rocca tra i monti di Vizzini, è circondata di sorgenti, abbonda di campi da seminare, di frutte, di latticini ed ha terre di ottima qualità. Da Mineo a Vizzini quattordici miglia per mezzogiorno. Da Mineo a Caltagirone dieci miglia per ponente. Da Mineo a Qal’at ‘al Far (La rocca del topo) tre miglia per tramontana…”(4)
Un’altra citazione di Calthaelfar, aggiunse Michele Amari, commentando in una nota il sopra riportato brano, la troviamo in un diploma del XI secolo.
Se teniamo conto che Militello non si trova citato, vien facile concludere che allora esso era soltanto un insediamento di poche case e di nessuna importanza. Il riferimento urbano era, forse, Catalfaro. Ciò, a maggior ragione, se pensiamo alla natura del genere letterario di cui Edrisi fu insigne rappresentante. Infatti:
“La letteratura geografica (…) nasce da itinerari (masalik) formatisi per bisogni commerciali oltre che politici e religiosi, e allaccianti in una fitta rete di strade le varie regioni dell’Impero. Per queste strade passano i mercanti, nerbo della vita economica medievale, che trasportavano da un capo all’altro del territorio islamico e anche oltre, tra gli Infedeli, i prodotti dell’agricoltura e dell’industria arabo-musulmanna”(5).
Fra l’altro, Edrisi non risulta l’unico autore arabo che cita Catalfaro. Quando descrivono questa parte della Sicilia, ne parlano praticamente tutti. Ne parla, soprattutto, ‘Al ‘Umari, detto pure ‘Ibn Fadl ‘Allah(6), segretario damasceno, citandola fra le rocche più importanti di Sicilia (per la zona del Calatino, insieme a Caltagirone e Mineo).
Quanto detto, evidentemente, per noi comporta la conseguenza di uno spostamento della fondazione della città di Militello a una data molto posteriore a quella d’epoca romana correntemente accettata. Il suo castello può farsi risalire alla politica di nuovi insediamenti cristiani, dopo l’arrivo dei normanni in Sicilia nel 1078, magari subito dopo la distruzione della roccaforte araba di Catalfaro.
Note
- Cfr. Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, Editori Laterza, Bari, 1970, p. 10;
- Anonimo della metà del 900 (quasi sicuramente, secondo Michele Amari, un cristiano, probabilmente siciliano, forse vissuto a Palermo, segretario o computista di un diwan dei principi Kalibiti dell’isola), Tarih gazirat Siqilliah (altrimenti chiamata Cronica di Cambridge), traduz. di Michele Amari, in Michele Amari, Biblioteca arabo-sicula, Ermanno Loescher, Torino e Roma, 1880 (ristampa anastatica: Dafni, Catania, 1982), vol. I, p. 278;
- Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, op. cit., p. 11;
- ‘Abu ‘Abd ‘Allah Muhammad ‘ibn Muhammad ‘ibn ‘Abd ‘Allah ‘ibn ‘Idris, Kitab nuzhat ‘al mustaq…, traduz. di Michele Amari, in Michele Amari, Biblioteca arabo-sicula, op. cit. vol. I, p. 105;
- Francesco Gabrieli, Gli arabi, Sansoni, Firenze, 1966, p. 133;
- Sahab ‘ad din ‘Abu ‘al ‘Abbas ‘Ahamad ‘ibn Yahya, ‘al Birmani, ‘al ‘Umari, più noto sotto il nome di ‘ibn Fadl ‘Allah, al Katib ‘ad Dimisi, Masalik ‘al ‘Absar, in Michele Amari, Biblioteca Arabo-sicula, op. cit., p. 263.
II
I BALDANZA E LA CULTURA DELLE CORTI A MILITELLO
1. Dal Gotico al Rinascimento.
Al periodo della signoria dei Barresi di Militello risalgono alcune Madonne che rappresentano esempi notevoli di figurazione artistica.
La prima è La vergine col Bambino e due angeli inginocchiati (fig. 2), una scultura in arenaria del tardo ’400, posta sopra il portale della chiesa di Santa Maria la Vetere. Ha avuto diverse attribuzioni: Enzo Maganuco(1) non ha escluso la collaborazione di Francesco Laurana, Gioacchino Di Marzo ha parlato di fattura gagginesca, Stefano Bottari l’ha ritenuta opera del carrarese Gian Battista Mazzolo. La personalità dell’autore, in ogni caso, appare già caratterizzata dalla disposizione delle figure secondo canoni razionali. La circolarità della lunetta (esaltata dal profilo delle ali degli angeli e tendenzialmente ripetuta dalla curva dei loro corpi inginocchiati) racchiude un quadrato, entro il quale s’incastra come un triangolo l’immagine di Maria. Il bilanciamento dei volumi e dei chiaroscuri risulta preciso, anche se il panneggio è alquanto tormentato e la dolcezza del viso della Vergine propone un forte impatto emotivo. Inoltre, la positura frontale della figura, di sapore arcaico, fa dell’opera un tardo esempio di gotico internazionale.
Secondo il Maganuco, di scuola lauranesca sembra un frammento marmoreo raffigurante la Vergine Annunziata. Purtroppo, il viso è in parte corroso, ma tipici del Maestro dalmata, sempre a detta del Maganuco, sono il ritmo del drappeggio e la curva nell’angolo che iscrive la figura.
La scuola del Gaggini è rappresentata da una serie di formelle a bassorilievo trovate in Santa Maria la Vetere e da una Madonna col Bambino, statua attualmente ubicata nella sagrestia della nuova Santa Maria della Stella. Anche qui convivono esperienze culturali diverse: l’arcaismo nella rigidezza della figura, la dolce espressività catalana nell’ovale del viso e, contemporaneamente, il drappeggio sobrio, largo e naturale. Si intravede, inoltre, la concezione “matematica” dell’opera, per la quale il volume rappresentato dal Bambin Gesù viene equilibrato nel lato opposto, ponendo Maria con la spalla leggermente alzata, col braccio all’altezza del seno e col ginocchio piegato in avanti.
Un cenno particolare, ancora, merita un quattrocentesco Cristo morto di Ignoto, opera oggi conservata all’interno del Museo “San Nicolò”. I particolari anatomici qui esaltano le sofferenze patite durante la flagellazione prima, e sulla croce dopo, con nuovi effetti di feroce realismo, specchio di una cultura ormai “terrena” che andava ponendosi come alternativa alla ieraticità del Gotico.
Un discorso più ampio, invece, merita il bassorilievo Ritratto di Pietro Speciale (fig. 3, ora nella Stanza del tesoro in Santa Maria della Stella), che l’Agati ed il Mauceri hanno attribuito a Francesco Laurana; ma che più probabilmente fu opera di Domenico Gaggini, secondo una recentissima indagine dell’arch. Di Stefano della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania. Esiste, infatti, a Palermo un Ritratto di Pietro Speciale,tuttotondo di sicura attribuzione al Saggini(2), del quale il bassorilievo risulta praticamente una copia. Di quest’opera, Enzo Maganuco e Leonardo Sciascia hanno parlato in termini entusiastici. Di certo, essa, nel migliore spirito rinascimentale, appare la concretizzazione di un ideale di umanità che vuol essere universale ed eterno. Più che le fattezze di Pietro Speciale, infatti, essa tratteggia il concetto di forza e di autorità. Le linee sono marcate e decise, senza indugi nei particolari. Il viso è teso e concentrato: mento prominente e volitivo, labbra serrate, sguardo attento e penetrante. Vengono, così, sintetizzate nell’espressione di un attimo il carattere e la volontà di tutta una vita, di tutta un’epoca.
Di quegli stessi anni, inoltre, ci restano alcuni capolavori che vanno ben oltre gli interessi localistici. Potremo cominciare citando il Sarcofago di Blasco II Barresi (fig. 4) posto in Santa Maria della Stella. Nella parte superiore esso rappresenta un’ottimo esempio di monumentalità; ma, il suo interesse maggiore sta nella parte inferiore, dove insieme alle eleganterie cortesi, indizio di non dozzinali modelli di vita, vi sono accenni di fughe prospettiche che vanno a definire lo spazio; il che impone in qualche modo una revisione dei giudizi sullo stile gotico, nel senso che già allora, almeno in Occidente, entrarono nell’arte i concetti di rappresentazione della realtà, poi maturati pienamente col Rinascimento.
Nel 1487, ancora, come ha dimostrato Salvatore Troìa(3), dai Barresi di Militello viene liquidata la somma per l’acquisto di una Natività in ceramica di Andrea Della Robbia (fig. 5, oggi collocata in Santa Maria). L’opera è divisa in tre parti. Al centro è raffigurata la nascita di Cristo in un contesto gaio ed elegante. Gesù sorride, non in una grotta, ma tra le razionali linee di una capanna. I pastori hanno una grazia arcadica. Gli alberi sullo sfondo danno freschezza e colore all’ambiente. Nella parte superiore un Dio sereno benedice la scena. In quella inferiore è rappresentata la passione, quando tutto consumatum est, in un equilibratissimo bilanciarsi di figure. Siamo davanti a un Rinascimento, se vogliamo, un po’ minore, privo delle aspre tensioni ideali dei pionieri, dominato da un’esteriore eleganza. Un operare artistico che ricorda più il Ghiberti che il Brunelleschi, più Gentile da Fabriano che Masaccio, più il gusto che l’intelletto.
Invece, nell’Annunciazione del 1572, prima nella chiesa di San Francesco di Paola ed ora nel Museo “San Nicolò”, nei limiti della sua qualità esecutiva, abbiamo un bel gioco di intelligenza. La fuga prospettica delle architetture crea lo spazio e gli accostamenti cromatici sono eleganti, culminando nella luce viva dei gigli in mano all’angelo annunziante (l’ideale centro del quadro, il punto di raccordo tra il divino e l’umano). Il viso della Vergine è disteso; ha l’espressione serena di chi ha chiaro il senso dell’esperienza che si avvia a vivere. Davvero, qui bellezza ed intelligenza coincidono. Non vi è la rappresentazione di un mistero, ma la chiara esplicitazione di un fatto. E’ il trionfo dell’umanesimo un po’ pedagogico della provincia.
Pochi anni dopo, il 7 ottobre 1574, si ha ancora un non disprezzabile saggio del gusto per l’arte della committenza locale, poiché (così ci informa Giusy Larinà) allo scultore Antonio De Mauro di Bivona, per la conoscenza che ne aveva il pittore e scultore militellese Nicola Barresi, venne dato l’incarico di modellare un bel Sant’antonio Abate, oggi visibile nella chiesa di San Sebastiano(4).
Note
- Enzo Manganuco, Oggetti d’arte a Militello, schede, Biblioteca Comunale “Angelo Majorana” di Militello V. C.;
- Cfr. I Saggini, suppl. di “Kalòs”, Palermo, Edizioni Ariete;
- Salvatore Troìa, La pala della Natività di Andrea della Robbia e la sua cappella in Santa Maria la Vetere a Militello, in “Lembasi”, archivio storico, Museo San Nicolò, Militello in Val di Catania, anno I n. 2, dicembre 1995, pp. 51-84;
- Giusy Larinà, Note documentarie sull’attività artistica a Militello in Val di Catania nei secoli XVI e XVII, Società Calatina di storia e cultura, bollettino 2/93.
2. Il San Pietro e storie.
Sul finire del secolo quindicesimo fu dipinto probabilmente il San Pietro e storie (fig. 6, ora nella Stanza del tesoro in Santa Maria della Stella). Infatti, nel catalogo su Antonello da Messina, pubblicato nel 1953, la data di esecuzione di questo autentico capolavoro è collegata all’attività di un Maestro della Croce di Piazza Armerina, operante tra il 1460 ed il 1480(1).
E’ un retablo, particolare tipo di polittico, con al centro la figura del Santo ed ai lati otto riquadri raffiguranti episodi significativi della sua vita. Eccone la successione:
- Vocazione del Santo;
- Resurrezione di Tabita (?);
- Liberazione di un’indemoniata;
- Punizione di Anania e Saffira, o Guarigione dei malati con l’ombra(?);
- Caduta di Simon Mago (?);
- “Quo vadis, domine?”;
- San Pietro e San Paolo davanti al proconsole;
- Crocifissione del Santo.
E’ stata attribuita a diversi autori. Si è parlato di Antonello De Saliba, di Pietro Ruzzolone (Maganuco e Bottari) e anche, in tempi recentissimi, di Antonello da Messina.
Su quest’ultima ipotesi val la pena di soffermarsi un po’, se non altro per l’enormità del nome messo in campo. Essa sembra già suggerita dal Mandel, perché “nell’impianto il complesso si presenta analogo alla distrutta pala di San Nicola a Messina.”(2) Un altro supporto a questa attribuzione, inoltre, si trova in due libri, uno del Minacciato(3) ed un altro di Caio Domenico Gallo(4), dove si accenna ad una pala di Antonello con dipinte “storie” di San Pietro.
In verità, in ambedue i libri non mancano gli errori e le deformazioni storiche(5). Ma, soprattutto nel primo, vengono da un maldestro tentativo di glorificare la città di Messina (cioè, di dimostrare la discendenza di Antonello da un’antica famiglia messinese e perciò non si vede quali motivi avesse di inventarsi un’opera inesistente). Il secondo libro, poi, si avvale delle indicazioni di Borghini, Vasari, Ridolfi, Boschini, Sansovino, Collier e don Francesco Susino (autore di un libro sulla vita degli artisti messinesi). Probabilmente, Antonello dipinse davvero un San Pietro e storie. Se non è il nostro, si tratta di un’opera andata perduta.
Che l’opera di Militello sia di mano antonelliana ce lo farebbe sospettare, inoltre, un documento del 13 marzo 1473, nel quale si attesta un pagamento al maestro per una “magnam yconam intaglatam”, ordinata dalla chiesa di San Giacomo di Caltagirone(6). Sul fatto, il Di Marzo svolse un ragionamento tendente a dimostrare che Antonello fece “altre gite e soggiorni… per quelle parti dell’isola.”(7) Lo Scalia, inoltre, suppone un lungo viaggio dell’artista per tutta la Sicilia nel periodo che va dal 1465 al 1473(8). In teoria, il San Pietro potrebbe essere stato dipinto in questa accasione.
C’è, ancora, il volumetto Rettifiche ed acquisizioni per Antonello di Giuseppe Consoli, che assegna ad Antonello, oltre al nostro dipinto, il Trionfo della morte nel portico Sclafani di Palermo e la Croce di Piazza Armerina.
Consoli parte dal “fatto che nessuna attenzione la critica rivolse allora (né ha rivolto successivamente) alla lettura che il Vigni aveva proposto di quella sorta di spina dorsale della pittura”(9) siciliana quattrocentesca rappresentata dal Trionfo della Morte nel portico Sclafani (da lì, fra l’altro, aggiungiamo noi, Picasso prenderà spunti per il suo Guernica), dalla Croce di Piazza Armerina e dal San Pietro di Militello. In questi tre lavori, secondo il Vigni, si trovava la radice degli apporti culturali europei che furono presenti in Antonello. Così, il Vigni era arrivato ad identificare due maestri: uno francese (autore del Trionfo della morte) e uno attivo nell’entroterra (autore della Croce e del San Pietro). In entrambi i casi, era comunque evidente la cultura del Sud della Francia.
L’analisi stilistica delle tre opere ha, però, portato il Consoli a ritenerle di una mano sola (e qui sta il punto debole del suo ragionamento; o, comunque, il punto che attende di essere meglio articolato). Appare, perciò, decisivo il fatto che egli scoprì nel Trionfo della morte, vicino alla data del 1462 ed alla firma di Guillaume Spicre (un insigne peintre-verrier, cioè decoratore di vetri), la seguente scritta:
“A(…)TO(…)LUS (…)SSA(…)ES(…)S.”
Riempiendo i vuoti prodotti dal tempo, è facile leggervi la firma di Antonello, forse all’epoca collaboratore dello Spicre.
In ogni caso, nell’opera militellana si sente il sapore di una cultura provenzale, con echi veneto-adriatici e liguri-emiliani, che ritroviamo in Antonello, per cui, se non di identità con lui, si può certamente parlare di similarità di radici, come recentissimamente ci ha confermato un passo di Teresa Pugliatti:
“…Successivamente vi saranno viste anche influenze antonelliane, confermate peraltro dal confronto tra una delle storiette del San Pietro e un disegno del Louvre dello stesso Antonello; sarà anche ripresa l’ipotesi, già avanzata da Zeri e da Vigni, di un pittore influenzato dalla cultura provenzale e, pur non escludendo del tutto la paternità del Ruzzolone, si riproporrà quella di un non meglio definito Maestro della Croce di Piazza Armerina.”(10)
E comunque, al di là dei problemi di attribuzione, l’opera merita grande attenzione per la posizione chiave che occupa nella storia della pittura siciliana. Il San Pietro, infatti è un felice ibrido in cui vecchio e nuovo convivono, senza sguiati contrasti e nello stesso tempo senza mai fondersi.
Così, nel pannello centrale del retablo il Santo siede nella gloria della cattedra in una positura arcaicamente frontale, secondo canoni antichi. Tutto in lui ed in ciò che lo circonda esprime dignità ed ieraticità regali: il gesto benedicente, lo sguardo dolce (ancor più ammorbidito dal capo leggermente inclinato), il ricco ricamo delle vesti e del tappeto, i due angeli ai suoi fianchi.
Di fronte, testimone di tanta gloria, sta un frate domenicano in preghiera e meditazione. Forse è lo stesso frate dei quadri del Beato Angelico, forse anch’egli si trova lì “per dire che quella è la visione dei vari misteri secondo la religione domenicana, le regole ascetiche dell’ordine. Non c’è natura né storia perché la regola pone i monaci in comunicazione diretta, senza bisogno di quei tramiti, con le verità della fede: dunque la fede è ancora un processo o un modo dell’intelletto, il più alto.”(11)
Ma, se si può fare a meno della natura e della storia per intendere San Pietro nella perfezione divina, la natura e la storia sono presenti nella sua azione terrena. Perciò, negli otto pannelli le regole della prospettiva costruiscono matematicamente lo spazio. La realtà, il teatro delle gesta del Santo, per essere realtà-realtà, è dipinta come realtà misurabile.
Guardate, per esempio, il riquadro che ci fa vedere La resurrezione di Tabita, il secondo verso il basso a sinistra di chi guarda. Lì, il Santo occupa uno spazio preciso, dato dal digradare delle colonne e dalle linee del pavimento che corrono verso il punto di fuga. Ogni figura vive ed acquista credibilità per un rapporto di dimensioni, che la mette in un rapporto spaziale. E’ la grande conquista dei quattrocentisti, la visione scientifica e laica del mondo, la terza dimensione che cattura la realtà così com’è (in pittura e contemporaneamente nella trattatistica politica del grande Machiavelli, quando indicò la necessità di guardare la verità effettuale).
Fino ad un certo punto, però. Nel dipinto non trova posto il disordine, anche se nella realtà esiste pur esso. Così, in un certo senso, proprio la realtà è ridotta a misura della capacità umana di perfezionare l’opera di Dio. Cominciò allora, forse, la bestemmia del totalitarismo scientista, fino alla sua più inquietante declinazione: l’ingegneria genetica.
“Conclusi gli anni di vigilia, i fervidi anni di preparazione in ambito meridionale, le esperienze di tipo pierfrancescano si focalizzano sul tema dello scandaglio spaziale dei volumi prospetticamente impostati e ruotanti nella sicura coscienza di una solare prospezione luminosa.”(12)
Sono parole che Raffaello Causa scrisse per Antonello, parole che trovano echi e fratellanze nello stile del San Pietro e storie di Militello.
Note
1. G. Vigni e G. Carandente, Antonello da Messina e la pittura del ‘4oo in Sicilia, Venezia, Alfieri, 1953, pp. 60-61;
2. Gabriele Mandel, L’opera completa di Antonello da Messina, Milano, Rizzoli, 1967, p. 90;
3.Minacciato (Giovanni di Napoli Ruffo d’Alifia?), Storia dell’illustrissima arciconfraternita di nostra Signora del Rosario…, Napoli, I. Russo, 1755;
4. Caio Domenico Gallo, Annali della città di Messina, Messina, 1756;
5. Cfr. Gioacchino Di Marzo, Antonello da Messina ed i suoi congiunti, Palermo, Edizioni Librarie Siciliane, 1983, pp. 3-5;
6. Gioacchino Di Marzo, Nuovi studi e appunti su Antonello da Messina, doc. XI, Messina, 1905, pp. 107-108; oppure, Salvatore Tramontana, Antonello e la sua città, Palermo, Sellerio, 1981, p. 105;
7. Gioacchino Di Marzo, Antonello da Messina e i suoi congiunti, cit., p. 40;
8. Natale Scalia, Antonello da Messina e la pittura in Sicilia, Palermo, Edizioni Librarie Siciliane, 1981, p. 21;
9. Giuseppe Consoli, Rettifiche e acquisizioni per Antonello, Messina, Poligrafica della Sicilia, 1978, p. 26;
10. Teresa Pugliatti, Pittura del Cinquecento in Sicilia, Electa, Napoli, 1998, p. 74;
11. Giulio Carlo Argan, Storia dell’arte italiana, vol. II, Sansoni, Firenze, 1969, p. 150;
12. Raffaello Causa, Antonello, Milano, Fratelli Fabbri, 1977.
3. I Baldanza, tra Manierismo e feste barocche.
Dal 1612 al 1614 visse a Militello, operando “con divin pennello”(Tortelli), il toscano Filippo Paladini (Casi, 1544-Mazzarino, 1614). Egli si era formato nell’ambito del tardo manierismo fiorentino, per cui, quando, verso il 1601, si trasferì in Sicilia, ne diffuse le tecniche raffinate ed attente ai gusti degli aristocratici. Tuttavia, subì pure il fascino di certe atmosfere caravaggesche, anche se non ne colse il drammatico senso della morte. La sua, insomma, fu un po’ la banalizzazione della pittura del Maestro lombardo, dato che si perse dietro le eleganze e le esibizioni di virtuosismi tecnici.
Forse per questo trovò molti seguaci. Nella chiesa del Purgatorio, infatti, c’è una copia di una sua Madonna degli Angeli ed al suo gusto, o a quello di Caravaggio, potrebbe essersi rifatto l’Ignoto che dipinse San Pietro che comunica Sant’Agata, opera che si trova nei depositi del Tesorodi Santa Maria della Stella. In quest’ultima colpisce la carnalità con cui vennero raffigurati i due Santi e l’Angelo presente. Il piede di San Pietro, grosso e contadinesco come quello del San Matteo del Caravaggio, ed il seno di Sant’Agata, naturalisticamente pesante, fanno diventare il miracolo un accadimento vero, che si esplica in uno spazio preciso e coinvolge precise persone (descritte addirittura con scrupolo anatomico). Il messaggio divino si mischia alla materia. La poesia, non più fantastica invenzione, è espressione “della più profonda realtà umana”(Argan).
Evidenti influssi paladineschi si colgono pure in due opere, Nascita e Decollazione di San Giovanni (anche queste presenti nei depositi del tempio mariano), sulle quali sono state trovate le firme del calatino Alessandro Comparetto (ed in una la data del 1631). In esse, purtroppo, il dramma manca del tutto: il truce carnefice ha la grazia vetrinesca dei manichini, non un fremito di vita spira dai personaggi. Espressione della devozione e del decoro ufficiali, i dipinti si fanno apprezzare soprattutto come testimonianza, oltre che per certe stesure cromatiche e qualche particolare ben risolto.
Di Filippo Paladini, invece, ci restano una Madonna degli Angeli (ubicata nell’omonima chiesa), un San Carlo Borromeo (fig. 7) e un San Francesco (fig. 8, col San Carlo nel Museo “San Nicolò”).
In queste produzioni, così, possiamo leggere tutte le inquietudini della controriforma. Le luci sono radenti e taglienti. Eppure, come s’è già detto, perduto dietro gli sfoggi tecnici, raramente egli crea il dramma. Si vede che siamo nel secolo dove, come scrisse il De Sanctis, la “vita interna è naturalismo in viva opposizione con l’ascetismo”. A ben guardare, l’arte sull’arte, tipica dei manieristi, è disperazione. Ammette l’impossibilità di parlare della vita. Di più, essa ha il sospetto che, nell’indifferente scorrere del tempo, la vita non esista.
Un manierismo di più disimpegnata eleganza si esprime nel movimento sinuoso ed ascensionale delle linee della Madonna del Rosario, scultura in legno policromo attualmente posta nell’Abbazia di San Benedetto.
Nei depositi del Tesoro di Santa Maria della Stella, invece, c’è un’interessante Madonna della Stella di Giacinto Platania, pittore secentesco nativo di Acireale. E’ un’opera che si stacca dalla coeva cultura figurativa; ma, nel senso che essa guarda indietro. La Vergine, insieme al Bambino, è raffigurata frontalmente. La corona, lo scettro, l’espressione ieratica e lontana danno il senso più dell’istituzione che dell’intimità religiosa. Dal Platania ci viene l’immagine della potenza. Per lui sono passate invano le angosce caravaggesche. Il potere non pone e non si pone dubbi. Sic non transit gloria mundi.
Nella chiesa mariana troviamo, ancora, un’altra visione popolare della divinità, fatta di regalità e dolcezza, con la statua della Madonna della Stella (fig. 9), che la popolazione devota porta in processione, l’8 settembre di ogni anno. C’è pure, di non minore suggestione, un Cristo alla colonna (fig. 10), scultura lignea di uno stile vicino a quello di fra’ Umìle da Petralia.
Bisogna dire, infine, che l’arte dell’epoca ebbe degni rappresentanti militellesi nei due Baldanza.
Il primo, Giovan Battista Baldanza il Vecchio (sec XVI-XVII), fu forse parente dell’abate De Angelis. Nel 1601 scolpì una statua di San Leonardo per l’omonima chiesa; nel 1621 scolpì la statua di San Nicolò di Bari, titolare della Chiesa Madre. Nel 1631, sempre per la chiesa di San Nicolò, scolpì dodici statuette rappresentanti gli Apostoli. Fu, inoltre, autore della Bara di Santa Maria della Stella (1624) e delle Porte del tabernacolo di Santa Maria della Stella. Gli esemplari sopravvissuti della sua produzione si fanno ammirare per certa elegante morbidezza di forme, pur in una distribuzione di volumi che trasmette l’idea di una ferma dignità.
I dubbi sull’esistenza di un suo figlio, Giovan Battista Baldanza il Giovane, sono stati sciolti da due documenti che Giusy Larinà ha rinvenuto presso l’Archivio di Stato di Catania(6). Il primo è un atto di pagamento del 15 novembre 1629, in cui vengono menzionati due maestri Giovan Battista Baldanza, padre e figlio (quest’ultimo chierico). V’è, inoltre, il testamento “in articulo mortis” di Baldanza sr., datato 28 novembre 1631, nel quale Baldanza jr. viene nominato erede universale.
A questo, oltre alla committenza evasa insieme al padre, possiamo attribuire un San Paolo del 1644 e una Bara per San Giovanni Battista del 1651; ed, ancora, diversi lavori pittorici: il Sant’Isidoro (1630) e la Madonna dell’Itria (1631) per la chiesa di San Francesco di Paola, un San Biagio per la chiesa di Sant’Antonio di Padova, una Sant’Agata per la sacrestia del monastero omonimo e un enorme San Benedetto per l’Altare Maggiore della chiesa omonima (1646), dove il Santo, in mezzo ai suoi seguaci e ad alcuni personaggi armati di spada, indicava il libro della sua Regola tenuto da un monaco in ginocchio(7).
Una pala d’altare del 1694 va, infine, citata fra quelle che più impreziosiscono Santa Maria della Stella. Fu opera di un tardo caravaggesco sensibile alla lezione di Mattia Preti. V’è rappresentato il Martirio di San Bartolomeo. Vi si ammira l’”uso sapiente di bianchi e di rossi mortificati con neri anch’essi sapientemente usati”(Maganuco).
La ricchezza d’arte era il giusto contesto per le rinomate feste secentesche militellesi. Nel 1611 il Principe Branciforti pensò bene di pubblicare un bando per regolare la “solennità di nostra sig.ra Maria della Stella”. In esso si ordinava ai soldati di uscire con la divisa e le armi dei dì solenni, sotto pena per i contravventori di una multa di sei tarì e di quattro giorni di carcere. Inoltre, si ordinava ai creditori di non importunare i loro debitori per tutti gli otto giorni di festeggiamenti.
Si ha, inoltre, notizia che nel ‘500 e nel ‘600 in onore della Madonna si correva un palio e si svolgeva una fiera a cui accorreva la gente delle città vicine. Ancora, si ha la copia di una ricevuta datata otto settembre 1628, dove si davano un’onza e diciotto tarì a Giuseppe Pitradilo di Palazzolo, per uno spettacolo di equilibrismo sulla corda, dal campanile di Santa Maria al piano sottostante.
Un momento importante era pure la predicazione quaresimale. Secondo la testimonianza del Carrera, il predicatore, già agli inizi del ‘600, svolgeva la sua opera a Santa Maria tutti i sabati (e nella seconda e quarta settimana). Poi, intervenne l’accordo per cui si predicava in Santa Maria nella prima e nella seconda settimana continuamente, mentre la predica dell’Annunziata veniva fatta nell’omonima Chiesa. Alla stessa maniera, in San Benedetto si svolgeva quella di San Benedetto. La Predicazione della Bolla della S. Crociata, che durava tre giorni, veniva, invece, fatta in San Nicolò. Poi, la prima Processione delle Vocazioni, che si faceva di lunedì, andava a San Pietro; la seconda, di martedì, a San Giovanni; la terza, di mercoledì, a SantAntonio Abbate.
Nella Domenica delle Palme la processione andava a S. Antonio Abbate, ma non entrava in chiesa, per cui si apprestava l’altare nel piano davanti alla porta sud e lì si recitavano le antifone in versetti e le Orazioni del Santo. Dopo, partiva la processione che, passando dietro San Pietro, arrivava nella piazza davanti alla Chiesa Madre di San Nicolò. Qui il Clero ed i parrocchiani di San Nicolò entravano nel tempio, mentre il Clero ed i parrocchiani di Santa Maria se ne scendevano verso la loro chiesa. Quindi, tutt’e due le comunità, ognuna per i fatti propri, celebrava la Messa ed il Passio.
Quest’ultima notazione ci fa capire che già in quegli anni era in atto la lotta dei campanili (il Carrera la chiamò la “briga grande”), che per secoli ha opposto (e continua ad opporre) le comunità di San Nicola di Bari e di Santa Maria della Stella. Il che viene confermato dalle altre feste di secolare tradizione che si possono ricordare, sempre basandosi sull’autorevole testimonianza del Carrera: il Corpus domini, nella quale di mattina il Beneficiato di San Nicolò aveva la prerogativa di cantar messa in Santa Maria ed al Beneficiato di Santa Maria toccava l’Ufficio serale in San Nicolò; l’Assunzione, alla celebrazione della quale concorreva tutto il Clero, alternativamente un anno in Santa Maria e un anno in San Nicolò; San Marco, con una processione che si recava in Santa Maria ed in quell’occasione i provetti raccoglievano l’elemosina, che poi andava al Clero.
Note
1. Al riguardo cfr. Giuseppe Majorana, Le memorie inedite di Filippo Caruso, Catania, Tipografia Giannotta, 1916, ristampa anastatica a cura del Comune di Militello, 1990;
2. Al riguardo cfr. Vincenzo Natale, Sulla storia de’ letterati ed altri uomini insigni di Militello nella valle di Noto, ristampa anastatica. Catania, Boemi, 1997;
3. Un esemplare dell’opera fa parte della collezione di libri antichi del Museo Civico;
4. Il Museo Civico possiede una collezione molto ampia degli originali di queste opere;
5. Se ne conserva l’originale nel Museo Civico;
6. Giusy Larinà, Note documentarie sull’attività artistica a Militello in Val di Catania nei secoli XVI e XVII, Caltagirone, Società Calatina di storia e cultura, bollettino, 2/93;
7. Purtroppo, una colpevole indifferenza nei confronti del patrimonio artistico ne ha provocato in anni recenti la quasi totale perdita (è visibile soltanto la figura del monaco).Quel che rimane si conserva nel Museo Civico.
III
SEBASTIANO GUZZONE E LA SOCIETA’ BORGHESE
1. La scenografia nel Settecento.
Nel Settecento la storia di Militello prendeva nuovi sviluppi. Subentravano inediti concetti urbanistici, dove il centro era il luogo di spettacolarizzazione degli assetti mentali del potere. La ricostruzione che seguì al terremoto dell’11 gennaio 1693 fu l’occasione di un rivoluzionario impianto viario, giocato su assi lungo i quali le balconate barocche (fig. 11) erano il palcoscenico dove stava la “nobiltà di toga” durante le processioni e le feste patronali. Tutto in quel periodo diventò teatro: dalle messe alle manifestazioni di fede popolare, dalle feste patronali alla nobiltà che si faceva guardare mentre guadava. Non a caso, in questo secolo le Sacre Rappresentazioni raggiunsero livelli di particolare pregio.
Il Venerdì Santo soprattutto dette occasione a straordinarie recite all’aperto. In ciò probabilmente c’era la continuazione dell’attestata tradizione cinquecentesca di rappresentare la Passione di Cristo nella piazza di Santa Maria della Stella. Allora, come ci racconta il Carrera, lo spettacolo durava tre giorni e spesso la recita era in versi siciliani. In tale circostanza i Rettori delle Confraternite maritavano una o più povere “donzelle”. Poi, c’erano balli nella strada e nella piazza davanti alla Chiesa, “ragunandosi tutto il Popolo, poiché vi ballava l’istessa Sposa, li parenti delli Rettori e le più belle donne della Terra, delle quali di riguardevole e singolar bellezza Militello n’è doviziosa.”
Nei copioni ritrovati(1), comunque, risulta notevole la dimensione popolaresca dei personaggi. Maria ed i Santi che la contornano pensano e parlano secondo pregiudizi che oggi sarebbero inammissibili. L’ingiuria nei confronti degli ebrei è violenta e continua. Ciò inquieta particolarmente se si pensa che una zona vicina alla città si chiama Chianu ’e furchi, pianura delle forche (dove, si dice, furono impiccati gli ebrei).
Notiamo, ancora, che i santi non soltanto hanno espressioni poco cristiane nei confronti di chi ha ucciso Gesù, ma sono davvero dei benpensanti. Nei loro giudizi è assente ogni pietà cristiana, specialmente quando si riferiscono ai ladroni compagni di Gesù.
L’opera più antica che ho potuto consultare è datata 1749 e ne esistono diverse varianti (forse alcune precedenti). La sua lunghezza (che è quella media dei copioni) è di quindici facciate formato quaderno. Le grafie dei manoscritti appaiono diverse. Le varianti sono spesso tautologiche, per contenuto e natura dei sentimenti; oppure, frammentano fra più interlocutori alcuni monologhi; o, ancora, inseriscono didascalie meglio specificate. Qualche volta, le varianti presentano una maggiore audacia nei barocchismi. Pochi i ripensamenti evidenziati dalle cancellature (molti, forse, legati a dubbi interpretativi del manoscritto più vecchio).
Benedetto Laganà fu il più importante autore di tale genere di testi. Egli vestì l’abito dei frati cappuccini e si distinse come predicatore di vasta dottrina. Nel 1752 , presso Bisagni di Catania, pubblicò Il profeta abborrito, ossia Cristo al Calvario, ed alla sepoltura, azione sacrotragica, e nel 1755, presso Pulejo di Catania, Cristo condannato, anch’essa azione sacrotragica.
Scrisse, inoltre, altri sette drammi di argomento sacro: Cristo nel presepio, Il ritorno di Egitto, La gara dell’amore fra Gesù Sagramentato e Militello, Il vero omaggio a Gesù Sagramentato, Cristo nei tribunali, Il Compedio della passione, Cristo resuscitato. Il pregio di queste opere è la versificazione accattivante e musicale, che ben si adatta alla recitazione all’aperto. Il Laganà fu anche autore di un’Orazione panegirica in lode del glorioso martire S. Vito, protettore della città di Regalbuto, pubblicata presso la stamperia Valenza di Palermo nel 1759, ed altri suoi manoscritti erano conservati nella biblioteca del convento dei cappuccini di Militello.
Tutto il teatro del Laganà fu poi ristampato da un suo fratello presso la stamperia Valenza di Palermo nel 1763, col titolo generale di Il teatro del Cattolico, Opere sacre abbozzate dal padre Franc. Benedetto da Militello Predicatore Cappuccino della Provincia di Siracusa.
Il decoro artistico, invece, riguardò soprattutto l’architettura, forse per il fervore costruttivo che seguì al disastroso terremoto del 1693. Ottimi manufatti furono, per esempio, il palazzo Tineo (fig. 12), il palazzo Baldanza-Denaro, il palazzo Baldanza ed il palazzo Niceforo (fig. 13), oltre al bel portico della Chiesa del Calvario del Battaglia(2).
In quel secolo, perciò, il quadro difficilmente si pose come discorso finito, come microcosmo chiuso in se stesso. Esso, piuttosto, tendeva a diventare un elemento architettonico, parte di un più generale concerto visivo. Ne fu pregevole esempio il Coro ligneo nella chiesa di San Benedetto, fastosamente impreziosito (secondo la filosofia dell’ordine benedettino) con scene sacre a bassorilievo.
Era, inoltre, l’epoca dei frescanti. Di essi, i più aggiornati guardarono con attenzione l’opera dei decoratori romani e napoletani. La bravura consisteva nel rendere ricco il lampeggiare di colori e l’intrico delle decorazioni (fig. 14).
Nella Chiesa di San Benedetto, ancora, arrivò un’importante opera pittorica, L’ultima comunione di San Benedetto (fig. 16) di Sebastiano Conca (Gaeta, 1679-Napoli, 1764). Vi si apprezzano il disegno robusto e la severa, anche se troppo canonica, impaginazione; come d’altronde c’era da aspettarsi, tenuto conto della committenza del tempo, se vogliamo molto controriformista e provinciale.
In Sicilia i maggiori frescanti furono Olivio Sozzi e Vito D’Anna. Del primo vale la pena di ammirare La nascita della Madonna (fig. 15, la pala d’altare è posta in Santa Maria della Stella; il bozzetto esposto nell’annessa Stanza del tesoro). L’opera è piena di movimento ed unitaria al contempo. Il punto di massima attenzione è leggermente spostato a sinistra. Da lì si diparte una spirale di figure, che dal fondo buio, dalle viscere della terra, arriva al forte rilievo del personaggio in primo piano, per ritornare poi verso l’alto, su, fino a toccare il cielo. I partecipanti all’evento, nell’espressione dei visi e negli atteggiamenti, sembrano i protagonisti di uno di quei tipici e raffinati ricevimenti coi quali il Settecento andava incontro alla catarsi insanguinata della Rivoluzione Francese.
L’opera di Vito D’Anna, visibile nei depositi di Santa Maria della Stella, è un Viso di Maria di misteriosa e palpitante bellezza. Il Manganuco l’attribuì a “un pittore come il Tuccari, ma che abbia studiato a lungo il Reni” e, così, colse le ascendenze culturali del dipinto. In esso la stesura dei colori è concentrata. Il breve spazio dell’ovale del viso è ricco di inavvertibili passaggi di tonalità, di infinite temperature cromatiche. Nello sguardo della Vergine c’è una segreta inquietudine ed un’umiltà che contraddice i luccichii dell’epoca. Così, profondità d’introspezione e composta dolcezza fanno di questo lavoro una delle più alte espressioni artistiche che si trovano a Militello.
Bisogna dire, ancora, che nel 1986, durante il restauro di un’opera (proveniente dal patrimonio Jatrini) raffigurante una settecentesca Sacra Famiglia, è venuta alla luce una parte anteriore, datata 1739. Per mia scelta, i lavori sono stati portati a termine in modo che restasse buona traccia di ambedue le pitture. Così, si vede abbastanza per apprezzare nell’opera più antica, al di là della costruzione tozza delle figure e del disegno stilisticamente attardato, una certa freschezza popolare, quasi da presepio. La stessa mentalità popolaresca la troviamo in una Madonna coi Santi Francesco e Caterina, perché l’impaginazione è quella tipica delle immaginette sacre. Settecenteschi, ma vicini ai criteri compositivi secenteschi, sono, poi, quattro dipinti di buona mano: San Paolo, San Pietro, San Giovanni e San Giacomo. In essi vigorosi contrasti luce evidenziano i volumi. Le pennellate, sciolte e sapienti, tratteggiano i Santi, apparentemente senza alcun disegno preparatorio. L’autore sembra aver sintetizzato lezioni di pittura tonale con tecniche caravaggesche. Lo stile di queste tele fu ripreso nei mirabili portelli lignei della settecentesca Cappella Corbino (tutte queste opere sono oggi ammirabili nei depositi del tempio di Santa Maria della Stella).
Molto vivace fu, ancora, l’opera e l’arguzia del sacerdote, architetto, pittore e poeta don Antonino Luciano Scirè (1695-1759), figlio di un apprezzato capomastro, Antonio Scirè. Sue sono alcune poesie satiriche, dove l’arguzia fece tutt’uno con la passione di parte. Ebbe molta eco, infatti, un suo componimento, dove i coevi personaggi militellesi vennero, ad uno ad uno, impietosamente caricaturizzati ed un altro poemetto, in ottave siciliane, dall’inequivocabile titolo di La perfidia mariana.
Scrisse pure una farsa, Calcagnu e calcagneddu, recitandola personalmente con gran divertimento del pubblico e grande ira del Vescovo, che non trovò l’accaduto compatibile con la dignità di un sacerdote e quindi lo sospese dal celebrar messa. Egli, però, presentatosi al suo superiore, riuscì a divertirlo tanto, da farsi dare una dispensa speciale.
La produzione pittorica dello Scirè, pur corretta nel disegno e nella stesura dei colori, non superò il limite della mera testimonianza del suo interesse per questa espressione d’arte. Resta attestazione di un San Pasquale e San Gaetano in Santa Maria della Stella, di un’Addolorata in San Nicolò, di un Sant’Antonino in San Francesco d’Assisi, di un San Rocco in San Sebastiano, di una Deposizione dalla Croce nella chiesa del Calvario. Fu, inoltre, autore di una perduta Via Crucis affrescata nelle edicole lungo la strada del Calvario.
Nell’architettura, invece, il suo estro gli permise di raggiungere ottimi ed originali risultati, soprattutto nella Chiesa del Santissimo Sacramento al Circolo (fig. 17), che, nella facciata “rientrante” di ispirazione borrominiana, propone un gioco di linee dinamicissime ed ascensionali. Disegnò pure l’ultimo ordine del prospetto della chiesa di San Benedetto ed il prospetto della chiesa di Sant’Anna a Palermo.
Altro nome di artista militellese di quegli anni fu Salvatore Falcone (1756-1806). Autodidatta, fu maestro nel disegno e nell’incisione, prediligendo le piccolissime dimensioni. Eseguì copie da artisti famosi, ma seppe pure ritrarre con prodigiosa somiglianza personaggi e paesaggi di Militello. Vincenzo Natale ci dice di due boccioli di canna incisi da lui, dove le figure e i paesaggi erano ben distinti, nonostante lo ristrettissimo spazio. Si sa pure di un suo presepio con figure in rilievo non più grandi della metà di un dito, eppure ricco di particolari nettamente figurati. Per l’abilità nel disegno, molti ingegneri ricorsero a lui per un aiuto, aiuto che non negò mai a nessuno e dette sempre in forma anonima.
Note
- Archivio delMuseo San Nicolò;
- Giuseppe Pagnano, Un’opera inedita di Francesco Battaglia: l’Anfiteatro del Venerdì Santo in Militello inVal di Catania, in “Lembasi”, rivista del Museo San Nicolò, anno I, n. 1, Militello, 1995, pp. 11-45.
2. I Lavori Pubblici sotto i Borboni.
Molta della corriva storiografia sul regno borbonico in Sicilia ancor oggi appare perlomeno viziata ideologicamente. La retorica post-unitaria ce lo aveva presentato sotto una luce truce, dove l’estrema crudeltà si accoppiava alla somma inefficienza. “La negazione di Dio fattasi governo” così fu definito da un uomo politico inglese dell’Ottocento. Nasceva un luogo comune e, come sempre accade per i luoghi comuni, esso finì per ingessare ingiustamente un’azione amministrativa dove insieme alle ombre ci furono molte luci (alcune delle quali, fra l’altro, di notevole intensità).
A cominciare dall’istituzione del catasto, invece, il periodo borbonico fu un momento di razionalizzazione delle entrate, al quale seguì un concetto più oculato di spesa. L’idea di “bene pubblico” sostuì definitivamente quella di “prestigio” (o del principe, o della città). Le opere, perciò, divennero meno appariscenti, ma più utili.
Per dirlo, lascio perdere la storia della città di Napoli, su cui già Carlo Allianello, col romanzo L’eredità della priora, ha avuto modo di iniziare a proporre alcune radicali, ed oggi largamente accettate, revisioni. Mi attengo semplicemente al piccolo osservatorio dell’Archivio Comunale di Militello. La corrispondenza tra il Decurionato e le autorità provinciali, giudiziarie e delle città vicine ci dà l’immagine di un’attività sorprendentemente dinamica. Non ci sono i grandi progetti urbanistici ed architettonici pensati individualmente e calati dall’alto, non le grandi cattedrali. V’è piuttosto un più umile e più tenace programma di interventi infrastrutturali, dove magari c’è molta ingegneria e poco genio creativo; ma dove indubbiamente la vita collettiva fa un deciso passo avanti verso la modernità.
Almeno fin quasi agli Anni Quaranta del secolo, cioè fino a quando le fibrillazioni rivoluzionarie del ’48 probabilmente avvelenarono i rapporti tra governanti e governati. Questo, infatti, ho potuto evincere, mettendo in ordine cronologico i Lavori Pubblici indicati dalle carte d’archivio e che qui sotto presento, lasciando parlare i fatti e non le convinzioni, come sempre dovrebbe succedere quando si esercita l’arte della scrittura storica.
La più antica notizia ottocentesca d’epoca borbonica di “Lavori Pubblici” a Militello è del 1815, quando il perito Fragalà realizzò la canalizzazione dell’acqua della fonte Zizza da Piazza Maggiore a via Porta della Torre. Seguirono a intervalli opere di manutenzione e di miglioramento. Nel 1819 l’architetto Francesco Capuana effettuò un sopralluogo nella sorgiva della Zizza. Nel 1821 vennero fatti dei lavori di manutenzione della linea dell’acquedotto. Nel 1825 il mastro Mario Messina e gli eredi di Francesco Messina eseguirono “viattazioni e ripari” nella sorgiva della Zizza e tentarono la canalizzazione dell’acqua del Lembasi. Il 30/6/1831 venne affisso nei comuni di Scordia, di Vizzini, di Mineo e di Caltagirone il “primo avviso” per appaltare i lavori nell’acquedotto di Militello (se ne conservano le ricevute date dai sindaci). Nello stesso anno venne scritta dal perito Tinnirello una relazione sui “catusi” realizzati e fu data notizia dell’acquedotto cosiddetto della Strada Corta, costruito con “tombonelli(?) di calce e cenise(?), ed indi coperto di balatato nero, in cui passaro le acque piovane che raccogliono varie strade interne, non solo, ma pure lo scolo dei pubblici canali di detta Comune…” Nel 1832 vi fu l’appalto per la “conservazione dell’acquedotto e fontane.” Nel 1838 il mastro Salvatore Lo Drago di Messina si prese l’incarico di una “guida dell’acquedotto pubblico” (con le annesse riparazioni). Le acque arrivavano dalle sorgive Zizza, Lembasi, Santo Vito, Vanella, Francello.
Del 1819 resta una corrispondenza nella quale Giovan Battista Patricolo si impegnava a costruire dei fanali “a lume inglese” nei pressi del palazzo comunale, primo nucleo dell’illuminazione pubblica.
Il sette febbraio del 1820 venne pubblicato l’avviso per procedere all’appalto per la costruzione del nuovo orologio pubblico, seguendo i criteri stabiliti nella relazione del perito mastro Domenico D’Agata di Aci Sant’Antonio. Il macchinario doveva collocarsi sulla facciata della Chiesa Madre. Il successivo atto per procedere alla costruzione è datato 2 agosto 1820.
Il più antico avviso da me trovato per la costruzione della strada Scordia-Militello è datato 18 novembre 1823. Nel 1832 il Decurionato di Scordia procedette alla gara d’appalto per la costruzione della “Strada del Beveratojo, e di quella de’ Mulini”. Nel 1832 si avviarono le procedure per la “costruzione della strada di Militello.”Nel 1833 venne affisso l’avviso di gara d’appalto per la Strada delli quadri, che univa Scordia a Militello. Il 19 luglio 1833 uscì l’avviso per la “costruzione di Strada Purgatorio e riattazione Strada Colonna” a Scordia.
Nel 1827 il Sindaco di Scordia Giuseppe Brocchieri pubblicò un avviso per appaltare la costruzione di un “Beveratojo in Contrada Cava.”
Nel 1828, con buona pace di Ugo Foscolo, dal Governo Borbonico arrivò a Militello la notizia del decreto che imponeva di realizzare i camposanti fuori dall’abitato.
Il 20 aprile 1830, siccome non si vive (e non si costruisce) con la sola buona volontà, venne fissato con apposito avviso, datato 26 giugno 1830, il dazio di pedaggio “nelle strade rotabili di Sicilia.” In relazione a ciò, il 18 maggio 1830, venne annunciata l’apertura della rotabile che univa Catania con Palermo e Messina “per mezzo di due lunghi tronchi di strada che incontrano la consolare, uno ad Adernò, e l’altro a Ponte Minissale sopra Diana.” Nel dicembre del 1832, poi, si ricevette notizia che “si dee procedere allo appalto dei lavori necessari in alcuni punti della Strada di Villallegra, onde rendersi sicuro e continuato il tragitto dei passi pericolosi nella stagione invernale.”
Il 17 settembre 1830 dall’Intendente arrivò comunicazione ai Decurionati (come allora venivano chiamati i Comuni) “di quanto giovamento sieno gli alberi di ormeggio lungo le carrozzabili strade provinciali, pel comodo de’ viandanti, per la salubrità dell’aere, e pel legno che producono.” Per cui, concludeva l’intendente “sono sicuro che codesto Decurionato come fervescente del pubblico bene, bisogno non ha che d’un impulso, per procurare tra gli altri ai suoi concittadini, utilità siffatte.”
Il 7 ottobre 1830 a Scordia si procedette all’appalto per costruire il palcoscenico del Teatro Comunale. Nel corso di quello stesso anno a Palagonia s’iniziarono le procedure per restaurare le prigioni comunali e a Caltagirone vennero emessi avvisi per appaltare la cosruzione di “strade interne.”
Nel 1831 dall’Intendenza del Valle di Catania arrivò una lettera circolare a stampa nella quale si dette avvio ad un’indagine sullo stato dei ponti e sulla loro riparazione nelle strade della provincia (o valle, come all’epoca si chiamava).
L’8 settembre 1832 venne pubblicato un “primo avviso”, nel quale “si concede al pubblico incanto l’appalto delle opere di adattamento e di formazione della casa di correzione nel terzo piano” del carcere centrale di Catania. Contestualmente uscì il “secondo avviso” per “l’aggiudicazione dell’appalto delle opere di formazione e perfezionamento delle due strade di Levante e di Ponente, e de’ due piani di mezzogiorno e tramontana al dintorno” del carcere, “nonché della fida ossia manutenzione delle stesse opere per anni cinque consecutivi.” L’avviso venne reiterato il 10 dicembre 1832 per le due strade e l’11 per il carcere. Nello stesso anno vennero affissi avvisi di gare d’appalto per la riparazione delle pubbliche prigioni a Vizzini, Caltagirone, Mineo e Palagonia. Vi fu pure in quell’anno una denuncia del Regio Giudice Rosario Ventimiglia sul diroccamento del carcere di Militello, per cui nel 1834 tali acconci vennero realizzati. Il 5 novembre 1836 uscì il “primo avviso” per procedere all’appalto per la costruzione di sei gratoni di ferro per le finestre dell’ospedale del carcere.
Sempre nel 1832 vengono realizzati dal Decurionato di Militello “acconci ne’ casamenti dell’ex feudo di Francello.”
Nel 1833 vi furono lavori di riparazione nella Casa Comunale di Palagonia.
Il 7 ottobre 1836 fu pubblicato il primo avviso per costruire “taluni muri parapetti sopra tutti i riempimenti che si alzano dal suolo al di sopra di palmo uno nella strada provinciale da S. Antonio a Diana.” Altro “primo avviso” vi fu il 7 novembre dello stesso anno per un identico lavoro nella strada provinciale da S. Antonio a Minissale. Mentre, datato 31 ottobre 1836, si trova un “secondo avviso” per “riattazione, e manutenzione della strada da Nicolosi, Gravina alla Barriera nella strada del bosco.” Il 6 novembre successivo si procedette, poi, all’appalto per la manutenzione della strada provinciale dal Borgo a S. Antonio, chiudendo il collegamento per arrivare a Diana, e quindi a Ponte Minissale, e quindi inserirsi nella consolare per Palermo e Messina.
Il sistema repressivo borbonico fece capolino sul finire del Regno, dopo i disordini del 1848, con un bando per la censura sulla stampa emesso nel 1850(1).
Note
- Tutte le notizie riportate sono state prese nell’Archivio Storico del Comune di Militello, busta 783 e segg.
3. Sebastiano Guzzone.
Neppure nell’Ottocento, però, a Militello mancò la creatività figurativa. Per esempio, al militellese Emanuele Fagone (1799-1859) con tutta probabilità si deve attribuire la maggior parte dei Ritratti di parroci presenti nelle due parrocchie della città. Sua è pure una Madonna della Stella dipinta su vetro, attualmente ubicata nella sacrestia di Santa Maria della Stella. Fu, inoltre, insieme a Nicolò Culosi (1802-1876), apprezzato incisore(1).
Le immaginette sacre del Fagone e del Culosi, insieme ad alcune altre coeve (figg. 18 e 19), sono oggi visibili nel Museo San Nicolò e nel Museo Civico, testimoni di una produzione locale dovuta ad una committenza popolare dai gusti semplici (ma non volgari). Al riguardo, purtroppo, ho dovuto constatare che il tempo e disgraziati eventi hanno del tutto cancellato la firma di un Biagio Sa(…)o, forse un napoletano, che nel 1832 dipinse un Sant’Alfonso sorridente e paterno (oggi nei depositi del Tesoro di Santa Maria), che nella città dovette piacere molto, dato che fu ripreso nella produzione dei nostri due autori.
Ma, il più grande artista militellese del secolo fu Sebastiano Guzzone (1856-1890), che si formò a Roma, nello studio di un copista di nome Filippo Casabene. Passò poi all’Accademia di San Luca, vincendo premi e borse di studio.
Si fece notare fin da giovane per la scioltezza del disegno e la ricchezza delle soluzioni cromatiche. Fu pregevole acquarellista, anche se il plauso non mancò neppure ai suoi quadri ad olio. I suoi soggetti, seguendo la moda romantica, predilissero le rievocazioni storiche. Ne ricordiamo alcuni titoli: Presentazione della sposa (costumi veneziani del secolo sedicesimo), Il premio al vincitore della giostra, Amleto che rifiuta i doni di Ofelia (eseguito per un banchiere di Manchester), Il primo nato, La funzione nuziale, Il traditore schernito, Festa in chiesa (attualmente nel Museo d’Arte Moderna di Roma), La morte del tetrarca e molti ritratti.
A Militello, di suo, nei depositi di Santa Maria della Stella resta un Ritratto del Vescovo Morana, perfetta raffigurazione del “decoro” ecclesiastico ottocentesco, dove l’eleganza degli abiti, esaltata dal prezioso anello che spicca su una mano molto curata, incornicia l’espressioneaustera del viso.
Nel Museo Civico c’è, poi, un Ritratto di donna (fig. 20, probabilmente, la moglie, donna Gaetanina Baldanza), dove il fermo disegno di impianto neoclassico, ingentilito dalla straordinaria morbidezza delle pennellate, si scioglie in libere macchie nella figurazione degli abiti, con esiti echeggianti le ricerche coeve a Napoli ed in Toscana (del De Nittis, in particolare, pittore che come Guzzone fu frequentatore dell’ambiente parigino).
Sempre nel Museo Civico c’è, inoltre, un Martirio di Santa Caterina (fig. 21), bozzetto su cartone per una pala d’altare, non firmato ma attribuibile al Guzzone, per i passaggi tonali morbidi che costruiscono i lineamenti dei volti.
C’è, ancora, nella mia collezione privata una sua matita giovanile, lo studio di una statua classica, nella quale l’esattezza della descrizione anatomica si coniuga mirabilmente con la dolcezza dei passaggi chiaroscurali.
Di lui scrisse un anonimo (Alfredo Entità?) in una cartolina dedicatagli post mortem:
“Presente in mostre nazionali di maggiore interesse, viene più volte premiato e lodato dalla critica. Stimolato a manifestare un suo linguaggio, va a Parigi a contatto di quel rinnovamento pittorico. Qui accentua la già ricca tavolozza acquistando rinomanza specie di delicato acquerellista. Tiene studio a Roma e a Firenze ma è spesso a Londra e a Parigi dove lascia molte opere. Nel 1887 viene premiato a Venezia con medaglia d’oro per la Morte di Petrarca… La Scena in giardino degna di un Corot, uno soprattutto degli autoritratti e alcuni ritratti di famiglia, sebbene veristi, sono opere altamente meritorie.”(2)
Personalmente, ritengo di poter condividere il riferimento a Corot, dato che in Guzzone la ricchezza delle architetture, il baluginare degli ori, il movimento dei drappi raggiungono la frivola piacevolezza del ricamo. Ecco perché ben presto i suoi acquerelli furono apprezzati e collezionati dalla borghesia di fine Ottocento (molto vivace fu, soprattutto, il mercato inglese). Così, oggi, se un limite vogliamo scorgere in lui, troveremo i sentimenti espressi un po’ troppo lievi e vaporanti. Lì con troppa facilità la storia si riduce al bel gesto e le realtà sociali più povere diventano sentimentalismo arcadico (ne è chiaro esempio, fra l’altro, il Pastorello malato, attualmente nel Museo del Castello Ursino di Catania). Anche quando, come dimostra proprio l’opera Scena in giardino, egli recepì certe novità della pittura “en plein air” degli impressionisti, lo fece in una versione inguaribilmente mondana.
Non a caso, egli espresse il meglio di sé nel carnevale romano del 1885, quando, insieme ad Ernesto Basile di Palermo e a Franciamore di Mussumeli, fu invitato a realizzare il carro carnascialesco rappresentante la Sicilia. Allora:
“Rimasero tutti soddisfatti del progetto redatto dal nostro Guzzone… L’insieme consisteva in una Conca d’oro… Il carro era trainato da tre pariglie di bianchi buoi con le corna dorate e guarniti di ricche gualdrappe infiorate… Rappresentava, insieme all’aquila, la regale Palermo. Detta Conca reggeva una figura slanciata di donna biancovestita che alcuni dicevano rappresentasse la Sicilia libera dal giogo borbone, poiché tutti i costumi dei partecipanti erano del tempo dei Vespri siciliani.”(3)
Fu perciò con legittimo orgoglio che il Nostro potè inviare allo zio prete, don Rosario Guzzone, che risiedeva a Militello, due grandi fotografie del carro, una delle quali è stata da me salvata per il Museo Civico (dove attualmente è esposta), con questa lettera di accompagnamento, datata 27 febbraio 1885:
“Vi ho mandato ieri in un pacco a mezzo posta due grandi fotografie del carro della Sicilia, che ho fatto io unito ai miei due amici siciliani. Il costume dei personaggi è del Trecento come ai tempi dei Vespri. Ai piedi del carro siamo fotografati io, il presidente del Comitato comm. Laganà, Basile, e Franciamore. Sopra il carro è il presidente della camera di commercio di Messina, che tiene in mano un tamburello ricchissimo da me dipinto, che abbiamo dato in omaggio alla regina l’ultimo giorno del carnevale nella via Corso a Roma…”(4)
Di particolare interesse e meritevoli di migliore valutazione mi sembrano, infine, certi suoi quadri religiosi, dove l’ortodossia cattolica, che poteva diventare angustia benpesante, sa riproporsi sotto le vesti di una poetica Metafisica in anticipo sui tempi. Ovviamente, si tratta di una Metafisica ancora priva della novecentesca inquietudine esistenziale che fu propria dei De Chirico, dei Carrà, dei Morandi. Nei lavori di Guzzone, però, si fa pittura un sorprendente e metastorico silenzio, dato che lo spazio si eleva a raffigurazione della voce pacata del Divino. Di tutto questo furono fulgido esempio: Interno della chiesa di San Francesco d’Assisi, Meditazioni del Petrarca su Sant’Agostino, Due benedettini del Trecento(5).
Oggi le sue spoglie stanno abbandonate nel cimitero degli artisti a Firenze e aspettano che una città meno sorda ai valori artistici le riporti nella terra che tanto mirabilmente seppe illustrare.
Note
- cfr. Giuseppe Pagnano, Immagini devote di Militello nei secoli XVIII e XIX, Militello, Edizioni del Museo S. Nicolò, 1986;
- Retro di una cartolina commemorativa per il Ritratto del pittore Sebastiano Guzzone, opera in bronzo dello scultore Carmelo Mendola, posta nei Giardini Pubblici, da dove è stata rubata nel corso degli anni Novanta;
- D. Mario Ventura, Sebastiano Guzzone, Catania, C.I.T.E.M., 1960, p. 34;
- D. Mario Ventura, cit., p. 35;
- Notizie in Angelo De Gubernatis, Dizionario degli artisti italiani viventi, Firenze, Le Monnier, s.d. (forse 1887, dato che pare pubblicato nell’anno della morte di Vincenzo Vela), p. 246.
IV
L’ARTE DELL’ITALIA UNITA
1. L’età degli ingegneri.
Dopo l’Unità d’Italia bisognò aspettare il 1877 per avere notizia del primo lavoro pubblico a Militello, che fu un intervento di restauro nel Monastero benedettino, diventato bene comunale in seguito all’esproprio dei beni ecclesiastici da parte del nuovo Stato.
Credo che tale ritardo denunci almeno un po’ disinteresse per il Meridione da parte del Regno sabaudo e spieghi in parte le difficoltà che esso incontrò nei primi tempi. I sudditi siciliani, infatti, poterono misurare i tempi nuovi soprattutto sull’aumento delle tasse e sulla coscrizione obbligatoria.
Senza contare i radicali ricambi della classe dirigente locale, che nella città avvenne dopo un grave fatto di sangue, quando nel 1869 venne ammazzato in una rissa il giovane Francesco Laganà Campisi. Subito dopo, il patrigno ed erede dell’ucciso, il deputato liberale Salvatore Majorana Calatabiano, accusò dell’omicidio il suo rivale in politica, il sindaco conservatore barone Salvatore Majorana Cocuzzella (che, poi, al processo venne assolto). In seguito a tale accusa, però, ci fu il definitivo tramonto del potere del Cocuzzella e una straordinaria ascesa politica del Calatabiano, che arrivò ad essere ministro di De Pretis (come, poi, suo figlio Angelo fu ministro di Giolitti).
Finalmente, tra il 1884 ed il 1885, ripartirono i Lavori Pubblici e vennero eseguite “opere al casotto dell’orologio Maria SS. Della Stella,” chiesa che era stata chiusa dai Borboni e che i Savoia avevano riaperto al pubblico. Nel 1887, poi, vennero eseguite “opere riguardanti il quadrante,” pagate da Francesco Garufi a Michele Rossello.
La vera e propria arte degli ingegneri a Militello (per usare una definizione in uso nei manuali scolastici, parlando dell’architettura di fine Ottocento e degli inizi del Novecento) comincia ad essere documentata con un progetto di edilizia privata a firma di Salvatore Mancuso datato 1884, oggi esposto nel Museo Civico.
La più antica creazione militellese di utilità pubblica dopo l’arrivo dei piemontesi in Sicilia di cui ho notizia, invece, fu del 1886 (contratto il 3/2 e consegna dei l’1/5). Trattasi di una Fontana in piazza S. Francesco (fig. 22) progettata da Federico Lombardo, purtroppo poi abbattuta nel corso del Novecento, il disegno oggi si può ammirare nel Museo Civico.
Nel 1887 Salvatore Capuana e Salvatore Mancuso, secondo il preventivo trovato nell’Archivio Storico del Comune, progettarono la “Costruzione del pianerottolo innanzi la Chiesa Madre San Nicolò attaccato alla piazza Vittorio Emanuele.”
Sempre nel 1887 gli stessi Salvatore Capuna e Salvatore Mancuso firmarono un Progetto Fonte Santo Antonio (fig. 23, collaudo dei lavori nel 1888), anch’essa distrutta nel Novecento (si è salvato il disegno, esposto nel Museo Civico).
Nello stesso anno cominciarono i lavori di sistemazione e di nuova costruzione delle strade interne. Infatti Salvatore Mancuso progettò la strada interna Quattro Cantoni (oggi via Pietro Carrera). Così, nel 1889 si verificarono alcune transazioni della Comune di Militello con dei privati a causa dell’effetto di ribassamento di strada Quattro Cantoni e della vicina strada Catena. Nel 1887 vi furono pure delle “sistemazioni di vicoli, cortili e traverse”, oltre al progetto di Salvatore Capuana e Salvatore Mancuso di Via Porta della Torre.
L’edilizia pubblica tenne conto, ovviamente, della nuova politica di istruzione popolare. Infatti, nel 1888 Giovanni Paride Mancuso fece “lavori di adattamento dei locali del Monastero di San Benedetto da Monte di prestito a scuole elementari.” Lo stesso progettò i “Lavori di riadattamento delle stanze dell’ex convento dei Fatebenefratelli a scuole femminili” (oggi nel Museo Civico). E si ebbe pure un appalto per i mobili da collocarsi nelle scuole elementari. Nel 1890 ancora Giovanni Mancuso collaudò la Sala conferenze delle scuole elementari maschili.
Nel 1891 Giovanni Mancuso realizzò il collaudo del Pubblico Macello.
Nel 1894, nella furia privatizzatrice del liberismo del tempo, il solito Mancuso elaborò un Piano Regolatore per la concessione del terreno della clausura del Monastero S. Agata oggi proprietà del Comune di Militello. Con ciò venne realizzato un vero e proprio “sventramento” del patrimonio storico, comportandone la perdita definitiva. Il che mi rende sommessamente discutibile la tesi dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan, molto di moda a sinistra, che vide negli “sventramenti” la caratteristica dell’incultura fascista.
La politica degli sventramenti, invece, mi pare tipica del tempo (ed era cominciata nella Parigi di Napoleone III). Infatti, il concetto venne ribadito nel 1895, quando Salvatore Capuana realizzò un Progetto strada per eliminazione curva zona Calvario, cosa che comportava il taglio di un intero quartiere. Forse i lavori iniziarono pure, stando ai ricordi degli anziani; ma, l’opera non fu mai portata a termine.
Nel 1898 P. Renna progettò l’Ampliamento della Caserma dei RR. Carabinieri in Militello nell’ex Convento di San Benedetto, oggi esposto nel Museo Civico, continuando a stravolgere il venerando monumento.
Agli inizi del Novecento, invece, risale la prima grande vera opera pubblica, il progetto dell’Orfanotrofio del cav. Salvatore Sortino (esposto nel Museo Civico). Lo stesso fu pure autore della Cupola liberty della chiesa di San Nicolò.
Nel 1900 Salvatore Niceforo Pace e Salvatore Capuana elaborarono il Progetto di sistemazione a selciato della via Mercato, Piano San Domenico, via dietro Majorana e piano Majorana. Nello stesso anno Francesco Deni fu autore del Progetto della strada Corso Vecchio e Corso Nuovo a Militello (oggi ambedue i lavori sono esposti nel Museo Civico).
Nel 1901 Francesco Deni realizzò il Progetto preventivo e capitolato d’oneri per la costruzione della via Sortino e piazzola Sant’Agostino.
Il 20 novembre 1905 venne affisso un avviso per le verifiche catastali (ora nella Raccolta di bandi del Museo Civico).
Nel 1910, a firma di Francesco Deni, fu presentato l’emendamento al Progetto della fogna di prolungamento lungo il torrente Santa Maria laVetere (ora nel Museo Civico).
Nel 1911 l’ing. Emilio Cardea progettò un Gruppo Scolastico (fig. 24) di elegante stile liberty. Peccato che l’opera non fu mai realizzata, anche se fortunatamente i disegni origiali sono visibili nel Museo Civico.
La cosa potrà dispiacere, ma col fascismo arrivò pure un nuovo slancio nel campo dei Lavori Pubblici. Infatti, già nel 1926 la Società Catanese di Elettricità, poi Imprese Elettriche Consoli, presentò i primi conti per l’appena impiantata illuminazione pubblica.
Nel 1928 venne affisso un avviso dove si dava un “premio di costruzione per la formazione e lo sviluppo di borgate rurali.” Sempre, nel 1928 ci fu il restauro della caserma dei carabinieri, allora allocata nel monastero dei benedettini.
Nel 1931 vennero liquidate alcune “spese per la costruzione aula scolastica San Leonardo. Dal 1932 al 1934 ci furono lavori di restauro e manutenzione degli edifici scolastici.
Nel 1932 vennero riparati i muri della “mandra della Badessa” e della “casa dell’ex feudo Francello.” Sempre nel 1932 ci fu la ricostruzione della tettoia del Monastero e chiesa di San Leonardo. Furono inoltre sistemati i locali dell’Ufficio Postelegrafonico. Venne ancora dato l’appalto di sistemazione del mattatoio pubblico (progetto esposto nel Museo Civico) e furono eseguiti i lavori di riattamento della pescheria.
Nel 1933 Francesco Anfuso progettò il nuovo edificio scolastico (fig. 25) in sostituzione di quello del Cardea. Questa volta lo stile fu, ovviamente, quello denominato Novecento. Neppure questo disegno, oggi esposto nel Museo Civico, trovò poi realizzazione (almeno, non nella forma esatta in cui fu concepito).
Nel 1934 lo stesso Anfuso progettò l’acquedotto Ciaramito Ortobasso.
Il buon gusto della committenza privata del tempo è, inoltre, attestato da una serie di progetti ospitati nel Museo Civico, quali il Prospetto da costruirsi in via donna Giovanna d’Austria (casa Anieri) firmato da Salvatore Niceforo Pace e datato 1934, il Progetto di monumento funerario per la fam. Marcinò firmato Salvatore Messina e datato 1937, il Progetto di sopra elevazione casa Abbotto firmato da Antonio Portuso, senza data ma evidentemente del periodo, e da una Sistemazione prospetto casa Rejna (figg. 26).
Probabilmente negli Anni Quaranta (secondo la datazione del progetto fattane dal nipote, geom. Salvatore Portuso) Antonio Portuso progettò il Campo Sportivo.
Nel 1941 ci fu la manutenzione del tetto della casa comunale. Nel 1943 vennero fatti lavori di manutenzione nel locale del Palazzo Comunale e nel 1944 ci fu la manutenzione “locali per uffici,” che continuò dal 1948 a seguire.
Note
- Notizie in Archivio Storico di Militello, busta 893 e segg.
2. Giovan Battista Filippo Basile.
Nell’arte siciliana della seconda metà dell’Ottocento le istanze veriste si scontravano e convivevano con audacie innovative. Soprattutto nell’urbanistica e nelle costruzioni. Si pensi che presidente del Circolo Artistico di Palermo era stato uno dei più innovativi maestri dell’architettura italiana, Giovan Battista Filippo Basile (1825-1891).
E, per quel che ci riguarda, la notizia non è indifferente, poiché Basile era venuto a Militello per i suoi legami di affetto con la famiglia militellese dei Tineo. Per l’esattezza, egli aveva potuto completare gli studi classici ed il corso universitario di scienze fisiche e matematiche, grazie al generoso sostegno del prof. Vincenzo Tineo (1791-1856), figlio del celebre Giuseppe(1) e secondo direttore dell’Orto Botanico di Palermo.
In verità, i maligni pensavano che Basile fosse il figlio naturale di Vincenzo Tineo e non quello legittimo del povero custode dell’Orto Botanico(2). Lo dico per una banale constatazione: o il paesaggio coniugale era variegato anche a quei tempi, o resta poco variegato quello dei maligni.
I viaggi del Basile, comunque, non restarono senza conseguenze sulla vivacità culturale e artistica di Militello. Infatti, nel 1887, Giovan Battista Filippo Basile assunse il compito di realizzare nella cittadina un Teatro Comunale.
Era un motivo enorme di orgoglio, poiché l’architetto aveva già avuto modo di percorrere tutti i gradi di una prestigiosa carriera. Basti dire che nel 1878 gli era stato dato l’incarico del progetto della Sezione italiana all’Esposizione Universale di Parigi. Il successo era stato tale che il governo italiano gli aveva conferito le due commende di San Maurizio e della Corona d’Italia e quello francese, oltre a chiamarlo a far parte della giuria internazionale per le Belle Arti in quell’Esposizione, lo aveva decorato con la croce di ufficiale della legion d’onore(3).
La storia del Teatro Comunale di Militello è una storia esemplare per capire quanta devastazione può portare la faziosità politica nella provincia. Per conoscerla, val la pena, senza molto togliere o aggiungere, di leggere ciò che sulla vicenda ha scritto Pio Salvatore Basso:
“Verso il 1875, con l’intento di trasformarlo in un pubblico teatro, il Comune di Militello acquista dal senatore Salvatore Majorana Calatabiano il fabbricato dei trappeti Pollina… Secondo il progetto estimativo del Basile (presentato il 5 agosto 1888) la mera somma occorrente per la costruzione del teatro ammonta a £. 76.597,62, rappresentando una piccola spesa in considerazione del gran monumento d’opera d’arte… che si sta edificando in Militello, e che fu sempre l’aspirazione di questa cittadinanza militellana.
“Ma, per quanto strano possa sembrare, con l’intervento prestigioso di Giovanni Battista Filippo Basile inizia la parabola discendente di un sogno a lungo accarezzato ma mai realizzato. Basile infatti morì nel 1891, i suoi rari viaggi a Militello, dove peraltro si dovette occupare di altri progetti di opere pubbliche, probabilmente non gli permisero di seguire meglio la direzione dei lavori della costruzione del teatro. Lasciò al comune cinque disegni per i quali vennero acquistate altrettante cornici coi rispettivi cristalli per esporli alla pubblica ammirazione in una sala del palazzo comunale (e di cui, a parte uno, non esiste traccia)… Nel 1903 si parla già di provvedimenti per la censuazione del fabbricato, per il fatto che il teatro lasciato in abbandono, senza tettoia, corre pericolo di demolirsi interamente e che risulta oneroso l’annuo canone enfiteutico di £. 550 da pagarsi agli eredi di Salvatore Majorana. Nel dicembre del 1906 nell’interesse della pubblica incolumità si decide di provvedere alla demolizione delle parti pericolanti e nel 1915 ad appaltare i lavori di demolizione del primo piano in quanto per il deterioramento della consistenza della muratura i mezzi perimetrali del teatro avevano perduto la primitiva solidità statica minacciando di rovinare con evidente pericolo dei passanti… Nel 1919 infine il regio commissario del Comune ordina la stima e quotizzazione del locale e dei manufatti del teatro… per poterlo vendere o concedere in enfiteusi ai privati.”(3)
En passant, aggiungo che in anni recentissimi (praticamente nel corso dell’ultimo decennio novecentesco) si è perso pure l’ultimo dei disegni originali del maestro, il che dimostra l’eternità dei ladri e degli amministratori poco solerti. Fortunatamente, ho potuto farne realizzare una copia a china (adesso esposta nel Museo Civico) dall’ing. Agata Maria Grazia Puglisi, partendo da una vecchia fotocopia (fig. 27).
L’aspetto interessante dell’intera storia è che le “eterne incompiute” non sono una prerogativa della politica contemporanea. La vicenda del teatro, infatti, trova una spiegazione nel fatto che, dal 1892 al 1915, arrivò il potere dei fratelli Benedetto (1854-1935) e Tommaso Cirmeni (1835-1910), come rissosa alternativa al precedente governo dei Majorana Calatabiano (che del Teatro erano stati gli sponsor). Tommaso, fra l’altro, costruì il suo palazzotto accanto all’area del teatro(4).
Per fortuna, anche se il suo Teatro Comunale non vide mai la luce, Basile poté lasciare traccia di sé a Militello come urbanista. Di particolare pregio, infatti, ancora oggi risulta la Via San Francesco di Paola, poiché il rigore geometrico con cui corrono le linee dei prospetti delle case, peraltro calibrate con la larghezza della strada, incornicia la facciata dell’omonimo convento, con un felice innesto tra le nuove esigenze di mobilità portate dalla modernità e il decorativismo secentesco.
Note
- In una carrellata dei personaggi prestigiosi dell’Ottocento militellese, in bell’evidenza, è quasi obbligatorio porre il naturalista Giuseppe Tineo (Militello, 1756-Palermo 1812). Era figlio di un dottore in legge, Vincenzo, e i suoi zii furono preti piuttosto reputati per la loro dottrina. L’ambiente familiare, quindi, fin da giovanissimo lo invogliò allo studio. Ben presto si trasferì a Palermo, dove, grazie all’opera illuminata del vicerè marchese Caracciolo e del suo successore, principe di Caramanico, cominciarono a nascere molte istituzioni di pubblica utilità (il primo Camposanto, l’osservatorio, le scuole normali, l’orto botanico). Il nostro Tineo, per la fertilità del suo ingegno, meritò di essere uno dei protagonisti, poiché, oltre ad essere cattedratico all’università, fu il primo direttore dell’Orto Botanico. Incombenza, quest’ultima, davvero difficile, se si pensa che, prima che gli venisse affidata, venne mandato a spese pubbliche nelle scuole di Pavia, dove entrò in contatto coi maggiori professori del tempo.
- Come si legge in Giuseppe Pagnano, Famiglia Tineo, in Militello dalla A alla Z, a cura di Nello Musumeci, Catania, 2003, p. 277;
- Per notizie più complete cfr. Dizionario degli Artisti Italiani Viventi, a cura di Angelo De Gubernatis, Firenze, Le Monnier, 1887, pp. 40/43;
- Salvatore Pio Basso, Teatro comunale, in Militello dalla A alla Z, cit., pp. 270/271;
- Nello Musumeci, Cirmeni Benedetto, in Militello dalla A alla Z, cit, pp. 100/101;
3. La cartolina a Militello.
A Militello, per comune destino della provincia, mancarono committenti prestigiosi sia per la cartolina, che per il manifesto. Vi furono soltanto onesti, ma limitati, proprietari di merceria, di tabaccheria e di un negozio di macchine per cucire, che si rivolsero a stampatori forestieri, o a qualche fotografo locale, tecnicamente dignitoso, ma non sempre di gusto straordinario. Rara avis furono le cartoline d’arte.
Per ciò che riguarda i manifesti opera di autori militellesi, nel 1970 ne uscì uno di Santo Marino, commemorativo della Liberazione; negli anni Ottanta ci fu una serie (di tre esemplari) sulla Settimana Santa sempre del Marino, un’altra (di due esemplari) sulla Cronoscalata Scordia–Militello di Elio Nicosia ed un pezzo singolo, molto bello, sulla Settimana di musica barocca di Salvatore Di Fazio.
Negli anni Novanta, invece, è uscita la serie sulla Sagra del ficodindia e della mostarda, alla quale, elaborando l’immagine di un dipinto di Santo Marino, hanno prestato la loro opera diversi autori (fra i quali io, nel 1994).
A parte, andrebbe fatto un discorso sui manifesti della Settimana del Barocco a Militello, dal 1994 in poi, di ineguali risultati, ma sempre affidati a operatori forestieri e quindi specchio di gusti piuttosto standardizzati.
Passando alla cartolina, diremo che la prima serie su Militello probabilmente ci viene dalla DIENA (Industrie artistiche riunite Torino). Dovrebbe comprendere più di undici esemplari numerati (da 19352 a oltre 19362). I soggetti sono quelli classici. Si presentano angoli tipici e pittoreschi (ben due panorami, il fiume Lembasi, la piazza di Santa Maria della Stella, il viale Regina Margherita, il parco delle rimembranze) e qualche opera civile di cui andare orgogliosi (l’orfanotrofio, per esempio).
Ne viene fuori un’evidente povertà. In queste cartoline Militello assomiglia a tutti i paesi decentrati. Lo si guarda dall’esterno, rendendolo un po’ anonimo. La data è da collocarsi intorno agli Anni Dieci (in ogni caso, è posteriore al 1904/1905, dato che solamente a partire da questi anni la parte destinata all’indirizzo occupa, come nella nostra serie, la metà del rovescio).
Il primo nome benemerito nella produzione militellese di cartoline è quello di Andrea Virgata, proprietario di un negozio di macchine per cucire. Il taglio delle immagini è più o meno uguale a quello della serie DIENA.
Ora il paese presenta soprattutto l’architettura (il castello, il municipio, le chiese, l’orfanotrofio). Apprezzare un monumento non richiede scarti di fantasia, né sforzi di pensiero. Il pensiero monumentale è il pensiero estetico della provincia. L’arte che ne deriva mette il sentimento al posto della bellezza.
Una maggiore attenzione all’arte può leggersi in una cartolina (produzione della parrocchia) dov’è riprodotto il sarcofago di Blasco II Barresi ubicato in Santa Maria della Stella. Di essa si hanno due varianti, una in grigio ed una in marrone.
Probabilmente intorno agli Anni Trenta, si ebbe la produzione di altre due immagini “artistiche”, in cui si vede la grande ceramica Natività di Andrea Della Robbia, pala d’altare in Santa Maria della Stella.
Intorno agli anni ‘40/50 e nei successivi anni ‘60 abbiamo prima una cartolina con alcuni versi del poeta militellese Giosuè Sparito (Enrico Fagone) e poi più di quattro cartoline dove sono riprodotti lavori del pittore locale Giuseppe Barone (un disegno ed alcuni affreschi eseguite nelle chiese di Militello e Carlentini. Infine, a metà degli anni ‘6o, uscì una bella cartolina con un disegno del pittore Santo Marino, Fratelli.
Esce pure, molto bella, una cartolina pubblicitaria della Farmacia Campisi, fotografata da Nicolò Sinatra, un vero e proprio Alinari (il testimone con le sue stampe della vita fiorentina) per la piccola Militello della prima metà del ‘900. Sinatra è anche tipografo ed a lui si deve un tentativo di produzione locale di cartoline. Se ne conoscono quattro esemplari, tutti di buon gusto, riproducenti affreschi.
Verso gli anni ‘40, una novità la portano le cartoline prodotte dalla cartoleria-merceria di Giovannino Scirè e dalla Cartoleria Barrasso: i fotografi firmano le loro immagini. Scirè utilizza fotografie di Nicolò Sinatra e di Vincenzo Musumeci. Barrasso usa quelle di Francesco Severino, di Gerardo Campisi, di Benedetto Barone, di Francesco Barrasso, di Nicolò Sinatra e di Santospagnuolo.
La cartoleria Barrasso è quella che ha dato più immagini di Militello. Nella sua produzione possiamo enucleare alcune serie, o in base alle scritte, o in base al fotografo, o in base al tipo di carta: 1) scritta frontale “Militello V.C.”; 2) scritta frontale “Saluti da Militello Val Catania”; 3) serie di fotografie di Santospagnuolo; 4) scritta frontale “Militello V.C.” su carta stralucida; 5) scritta frontale “Militello (Catania)”; 6) scritta sul retro.
Con Barrasso e Scirè, infatti, cominciò pure la produzione di cartoline su carta stralucida.
Sempre su carta stralucida sono i pezzi prodotti da Giovanna Cultraro, che si affidò All’Industria cartoline “A. Ragazzi” di Piacenza.
L’attività fu poi continuata dalla ditta Barone, con la quale probabilmente ci furono la prime cartoline colorate. Fanno seguito a questa produzione molte cartoline in BN senza indicazioni. Erano già gli anni ‘60, quelli del “boom” economico. In una cartolina di questo periodo si vede il fabbricato razionale ed estraneo del Banco di Sicilia.
Un discorso a parte meritano le cartoline prodotte dal cav. Francesco Di Stefano, cartolibraio. Le fotografie sono di Nino Chisari e raffigurano Gesù alla colonna e la Chiesa di San Benedetto su cartoncino leggero e matto, testimonianza che gli scarsi mezzi possono determinare un gusto ottimo.
Le chiese hanno avuto un ruolo importante nell’editoria delle cartoline. Bisogna dire, però, che, nonostante i tesori d’arte ch’esse custodiscono, spesso producono immagini dal gusto esecrabile. Le fotografie dei Santi sono quasi sempre piatte, dure, senza alcuna fantasia nel riprendere. Il cattivo gusto comanda, soprattutto nelle immagini a colori. Così, poche cose sono più orride di certe visioni militellesi dell’Immacolata, del Cuore di Gesù, del SS. Salvatore e della Madonna della Stella. Anche la Tipografia 2000 di Palagonia ha stampato alcune immagini del SS. Salvatore, con gusto documentaristico, ma accurato.
Finalmente, le serie di cartoline a colori (anni ‘70 e ‘80) sono quattro: la prima è senza indicazione di proprietà riservata; conta sette esemplari e dà documentazione soprattutto dell’architettura. La seconda, di cinque esemplari, è stata stampata dalla GM; in essa si prediligono gli scorci tipici. La terza, di quattro esemplari, è un’edizione della tabaccheria di Santo Marchese. La quarta, di quattro esemplari, è un’edizione delle sorelle Caminito.
V
GIUSEPPE BARONE, EPIGONO DEI MAESTRI FRESCANTI
- Il senso di un aneddoto.
Nei ricordi di Emilio Greco, Giuseppe Barone amava ripetere ai colleghi:
“A mmia m’arruvinarru i parrina!”(1)
Cioè: mi rovinarono i preti. E sarebbero parole strane, dette da chi portava a casa pane che sapeva di pittura e parrocchia. O forse del tutto normali, se pensiamo ai complicati rapporti che legano l’atto creativo alla borsa che lo finanzia.
Ovviamente, non mi riferisco soltanto al vile denaro, anche perché nel nostro caso a sua volta il denaro rimanda a qualcos’altro. E’ vero, gli artisti mangiano, odiano e s’innamorano come tutti. Ma, la disponibilità economica, per un pittore che pensa in grande, prima di rappresentare un guadagno, è la premessa per realizzare un’opera. La sua ambizione, perciò, potrebbe essere la storia (o, se vogliamo, l’esorcismo della morte).
“Il distacco fra letteratura e storia” ha scritto Hans Robert Jauss, “fra conoscenza estetica e storica, diviene superabile se la storia della letteratura non si limita a descrivere ancora una volta il processo della storia generale come si rispecchia nelle sue opere, ma quando essa scopre nel corso dell’ evoluzione letteraria quella funzione propriamente formatrice della società che nell’emancipazione dell’uomo dai suoi legami naturali, religiosi e sociali toccò alla letteratura in concorrenza con le altre arti e forze sociali.”(2)
Di mio posso aggiungere che un tal presupposto va in senso opposto alla ricerca di meccaniche corrispondenze tra produzione economica e produzione spirituale. Il rapporto tra artista e committenza c’è, ma è un rapporto dialettico. Anzi, di più: uno strano rapporto.
Mi hanno sempre affascinato, per esempio, i laccioli che legavano il cortigiano rinascimentale al suo signore. Ovviamente, uso il termine cortigiano distinguendolo dal volgare cenipeta, qual è l’adulatore imbecille. Il cortigiano aveva la consapevolezza della sua dipendenza; ma, al contempo, aveva maggior potere del suo padrone, dato che preparava il superamento della corriva visione del mondo.
Qualcosa di simile potrei dirla anche davanti agli affreschi di Barone e ciò fortunatamente darebbe torto alla sua frase contro i preti. Egli, infatti, seppur dipese da una committenza dalla mentalità ristretta, provò a vincere la sua condizione di servaggio, disegnando i personaggi con grande vigore chiaroscurale e perciò rendendoli dei tipi, anzi degli archetipi.
Il parallelo più immediato, a questo punto, è quello col coevo e laicissimo muralismo sironiano. Ma, non mancherebbero neppure i riferimenti alla nobile retorica carducciana, magari mediata dalla sensibilità del poeta conterraneo e contemporaneo Giosuè Sparito, dove il discorso vuol essere leggibile e magari amplificato per renderlo più forte.
Per spiegarmi meglio, mi permetterò di citare un suo cartone preparatorio che giganteggia nel mio studio. E’ un San Giovanni evangelista, con tanto di librone, penna d’oca ed aquila, a corredo dell’effetto monumentale che viene dal modo in cui sono delineati i particolari anatomici. Me lo vendette a metà degli anni Settanta quella strana sagoma di prete e di storico locale che fu il militellese don Mario Ventura (1913-1982). Ricordo il prezzo d’acquisto dell’opera: diecimila lire (allora il mio stipendio di insegnante superava di poco le duecentomila lire). Spesi molto di più per incorniciarla, dieci anni dopo: settantamila lire, mi pare (ma, con lo stipendio che si avvicinava al milione di lire).
Nel San Giovanni ogni particolare è frutto di una secolare esperienza pittorica. Lo sguardo del Santo si volge verso l’alto, perché dall’alto, fiducioso e sottomesso, aspetta le parole della fede. Sono, se vogliamo, i canoni del sentimentalismo che la Chiesa controriformista ha eletto ad unico sentimentalismo possibile. Però, poi il Nostro riconsegna a sé i suoi amori artistici, con riferimenti precisi (quali quelli a Giotto, ad Andrea del Castagno e ad altri rinascimentali). Realizza, quindi, materia solida in spazi chiaramente definiti. Il suo è un discorso accessibile a una cultura non avventurosa, vorrei dire contadina, un discorso svolto tutto all’interno della fisicità delle figure.
Con brutalità e candore, così, la narrazione teologica si fa solennità storicista. Possiamo, cioè, capire la mentalità (o le aspettative) del contesto dell’artista. Da qui il pregio del bozzetto. Esso ci dà una maggiore possibilità di scendere all’interno della visione del mondo che l’ha determinata. E’ come guardare dentro un orologio, vederne la legge che lo fa ticchettare.
Anche se, come ho già detto, ciò non basta a collocare nel giusto posto l’opera di Giuseppe Barone. Le immediate corrispondenze tra i temi trattati dal pittore ed i temi cari alla sua epoca sono una tentazione facile, ma c’è il rischio di perdersi in giochetti meccanicisti (dove, fra l’altro, tutto ed il contrario di tutto può sostenersi con pari legittimità).
Cercherò, quindi, di fare meglio. Tenterò una storicizzazione e forse la vera storicizzazione delle opere novecentesche sta nello storicizzare il bisogno di trovare l’archetipo unificante.
Pensate alle crisi di identità di Kafka e Pirandello, pensate alla babele picassiana dei punti di vista e capirete come anche un’esperienza artistica d’avanguardia quale fu la scultura astratta di Henry Moore, apparentemente la più lontana da quella di Barone, possa inquadrarsi nella ricerca di un archetipo, come per di più è stato sottolineato da Herbert Read:
“Tutte le opere di Moore hanno un rapporto più o meno diretto con questi due archetipi (la Madre col bambino e la Donna sdraiata, nota mia), che sono i suoi motivi dominanti. Alcune sono studi particolareggiati di ossa e di crani; talvolta la figura della madre viene privata del figlio, e altre volte viene aggiunto un secondo bambino, e persino un padre per formare insieme un Gruppo di famiglia. Talora la figura sdraiata si confonde con la madre per formare una figura in piedi, che a sua volta si avvicina ad un altro archetipo: la Croce o la Crocifissione. Lo spirito inventivo di Moore è come una fontana che non è mai tranquilla, che muta sempre forma, eppure rimane la stessa fontana, la fontana della Vita.”(3)
Note
(1) La frase mi è stata riferita dall’ing. Salvatore Troia, autorevole membro della comunità parrocchiale di Santa Maria della Stella. Egli mi ha raccontato che in occasione del collocamento sulle porte dell’altare della Madonna di due suoi Angeli in bronzo, Emilio Greco si dichiarò particolarmente onorato di trovare ospitalità nello stesso tempio che custodiva gli affreschi del suo amico Giuseppe Barone. Dopodiché, il Maestro riferì le parole del Barone per sottolineare la coscienza che questi aveva del fatto che la committenza ecclesiastica aveva chiuso la sua pittura entro i limiti di una cultura provinciale;
(2) Hans Robert Jauss, Perché la storia della letteratura?, Guida Editori, Napoli, 1977, p. 109;
(3) Herbert Read, Henry Moore, Silvana Editoriale d’Arte, Milano, 1966, p. 23.
2. Tra nuovi fermenti e vecchie logiche.
“L’anno milleottocentottanta sette, addì tre di ottobre, a ore ante meridiane dieci e minuti trenta, nella casa comunale.
“Avanti a me Avvocato Salvatore Campisi Assessore anziano funzionante da Sindaco Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Militello Val Catania, è comparso Agostino Barone, di anni ventotto, calzolajo domiciliato in Militello, il quale mi ha dichiarato che alle ore pomeridiane una e minuti trenta, del dì due del corrente mese, nella casa posta in Via Calvario al numero ———–, da Giuseppa Barresi industriosa sua Moglie seco lui convivente è nato un bambino di sesso Maschile che egli mi presenta, e a cui da il nome di Giuseppe…”(1)
Straordinaria, la prosa dei burocrati di fine Ottocento! Verga dichiarò di aver preso lo stile de I Malavoglia dal diario di bordo d’un capitano di nave. Se avesse scritto una biografia forse avrebbe cercato ispirazione in un ufficio dello Stato Civile. Cosa c’è di meglio, infatti, di quell’”industriosa sua Moglie seco lui convivente” per capire i valori morali di un paesino siciliano dell’epoca?
Siamo davanti a una mentalità molto diversa da quella contemporanea. Parrebbe che per quella gente la famiglia fosse un opificio. Lo dirigeva il padre; ma, la donna ne era il macchinario principale: dalla manifattura del cibo, alla filatura, alla tenuta in ordine della casa, alla produzione dei figli e (forse) qualche volta alla produzione del piacere. Nello specifico della coppia Agostino Barone e Giuseppa Barresi, dopo Giuseppe, l’un dopo l’altro, nasceranno Valentino (il 6/10/1889), Salvatore (il 19/10/1891), Marietta (il 19/3/1894), Antonino (il 2/8/1896), Benedetta (il 18/7/1902). Comincio a credere che la Rivoluzione Industriale, in fin dei conti, sia stata il passaggio da una dipendenza ad un’altra: prima si decideva la famiglia, ora l’apparato produttivo.
Come si vede, non è molta la libertà che s’è guadagnata, oltre ad essersi persa quasi tutta la poesia. Ma, ciò che in questa sede importa è il fatto che, una volta cresciuto, il nostro Giuseppe Barone ci restituì la mentalità dei suoi tempi sub specie aeternitatis, cioè fissandola in colore e figure. Per questo, cercando quella stessa mentalità ho iniziato la mia indagine riportando le parole dell’atto di nascita, così come le ho trovate (ho soltanto messo in corsivo le parti a penna poste negli spazi tra i caratteri tipografici).
Così, veniamo a sapere anche delle umili origini del nostro pittore. Eppure, come si legge nelle biografie finora disponibili(2), egli potette compiere i suoi studi nella lontana Palermo, prima al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti.
E qui vien fuori un’altra verità, per la quale non sempre c’è da fidarsi dei documenti scritti a stampa. Infatti, la notizia di un impegno scolastico liceale sarebbe un anacronismo, dato che le scuole statali d’arte in Italia furono istituite con i ventidue provvedimenti legislativi della Riforma Gentile, firmati fra l’ottobre del 1922 ed il dicembre del 1923.
L’Accademia palermitana, invece, nacque nel 1886 e, come nella più famosa Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, accedevano all’insegnamento prevalentemente artisti che:
“Si dedicavano ad imponenti composizioni di figura, inserendosi nella corrente nella quale le accademie furono protagoniste, dal tempo delle mitologie neoclassiche e dei soggetti storici a quello dei temi derivati dal romanzo.” (3)
Questo valeva soprattutto in Sicilia, per la ricca ed importante tradizione che l’isola ereditava dal Settecento. Infatti, lì:
“La transizione al gusto neoclassico fu avviata, nell’ultimo ‘700, dagli allievi di Vito d’Anna: Francesco Manno e Mariano Rossi; stabilitisi a Roma, ricoprirono importanti cariche all’Accademia di S. Luca ed assimilarono le teorie del Winckelmann alle quali si attennero nei lavori eseguiti a villa Borghese e al Quirinale; attivo soprattutto a Palermo fu invece Antonino Manno, stimato tra l’altro per gli affreschi al Palazzo Belmonte-Riso, oggi distrutti, e per quelli di largo respiro nella volta della chiesa dell’Olivella (1789).”(4)
Bisogna dire che, da questo punto di vista, Giuseppe Barone nacque fortunato. Crescendo a Militello, fin da ragazzino potè contemplare gli esempi altissimi della produzione di Olivio Sozzi e di Vito d’Anna(5) e credo che la scelta dell’affresco come principale espressione della sua attività d’artista venne dall’ammirazione per loro. Ancora nel ‘900, inoltre, l’affresco garantiva la committenza ecclesiastica, che era l’unica pensabile in una società non più signorile e non ancora industriale.
Perciò, nel 1903, a sedici anni, quando (grazie ad una borsa di studio del proprio Comune) arrivò a Palermo, Barone trovò i continuatori di una secolare tradizione, nei confronti della quale, però, non mancavano i tentativi di innovazione.
Non a caso la cattedra di Figura disegnata la teneva il pittore Luigi Di Giovanni (1856-1938), discepolo del grande Domenico Morelli. All’arte del Di Giovanni dobbiamo far riferimento per una prima comprensione della congerie culturale del tempo. In alcuni dipinti (per esempio ne Gli emigranti) alla retorica delle accademie egli aggiunse una certa sensibilità per i problemi sociali, o almeno una costante attenzione per la figura umana. Perciò:
“Anche nel paesaggio, luminoso e pastoso, egli spesso inserisce la figura umana, come nei Pescatori a Sferracavallo.”(6)
Barone, però, guardò pure alla pittura di Francesco Lojacono (1838-1915), che nella seconda metà dell’Ottocento raccontò una Sicilia nella quale una certa vivacità culturale si coniugava con forti tensioni sociali. In quegli anni, infatti, almeno a Palermo (e un po’ anche a Catania; per esempio, con le raffinerie di zolfo) la borghesia prese la guida dell’amministrazione pubblica e dell’economia. Così, fiorirono le dinastie-simbolo del Liberty come i Florio e i Whitaker.
Coerentemente, le opere di più antica datazione che ci restano di Barone posero l’attenzione sulla figura umana e sulle classi umili. Sono soprattutto disegni, di cui ho trovato traccia nell’Archivio fotografico del figlio Agostino, o nel catalogo della retrospettiva del 1956. Mi riferisco, in particolare, a due disegni di Contadinello del 1909, ad una Piccola cucitrice sempre del 1909 e ad un’Ostessa del 1912.
Nei primi anni del XX° secolo altro riferimento di Barone fu probabilmente il pittore scordiense Giuseppe Barchitta, che poi raggiunse una buona notorietà in Brasile. Infatti:
“Barchitta, in questi anni, conosce Giuseppe Barone, giovane pittore della vicina Militello in Val di Catania, del quale verosimilmente, prima del soggiorno di studio dell’artista militellese a Palermo alla scuola di Francesco Lojacono (1838-1915), se non il primo maestro, fu un immediato, e già maturo, interlocutore per l’apprendimento delle prime nozioni di pittura.”(7)
Note
- Comune di Militello in Val di Catania, Atti di nascita, n. 379, a. 1887;
- Cfr. soprattutto Retrospettiva di Giuseppe Barone, catalogo della mostra tenutasi al Circolo della stampa di Catania dal 31 marzo al 13 aprile 1956;
- In La galleria civica d’arte moderna di Torino, guida breve a cura di Rosanna Maggio Serra, Torino, s. d., pp. 12/13;
- Franco Grasso, Ottocento e novecento in Sicilia, in Storia dell’arte in Sicilia, vol. II, Palermo, Le edizioni del sole, 1984, p. 171;
- Una sua pala d’altare, fra l’altro, presente nella Chiesa Madre di Militello e raffigurante San Nicolò di Bari, gli è stata definitivamente attribuita soltanto negli ultimi anni; prima la si credeva opera di Mariano Rossi, come si legge in don Mario Ventura, Storia di Militello, Catania, Citem, 1953;
- Franco Grasso, op. cit., pp. 182/183;
- Claudio F. Parisi, Giuseppe Barchetta, Scordia, Nadir, 1996, pp. 40/41.
3. Le prime committenze pubbliche.
Ad un’amorosa capacità di rivisitazione del passato sembrò far riferimento Barone in una delle sue prime committenze. Fu la Copia del “San Carlo Borromeo” di Filippo Paladini, un disegno a matita oggi nel Museo San Nicolò di Militello, realizzato nel 1905, quando il pittore aveva diciotto anni.
L’incontro tra Giuseppe Barone e Filippo Paladini fu dovuto al restauro di una pala d’altare. Infatti, come ci dà notizia lo storico Giuseppe Scirè, trovandosi nella chiesa di San Francesco d’Assisi due quadri di Filippo Paladini, un San Francesco e un San Carlo Borromeo:
“Furono dichiarati dall’incaricato della Sopra Intendenza de’ monumenti antichi di Siracusa, cadaveri di quadri, poiché essi mancando di telai erano fissi con chiodi al muro ed attaccati dall’umidità trovavansi tutti a brandelli; però quello del S. Carlo, che trovavasi in migliore condizione degli altri, per ordine della Direzione Generale delle Belle Arti di Roma e della Sopra Intendenza di Siracusa, fu con mirabile maestria e somma perizia ristorato ed applicato su nuova tela in telaio dall’artista Prof. di disegno Giuseppe Barone, pittore di Militello, il quale ha saputo bene far rivivere quel quadro…
“E’ da augurarsi che anche pel S. Francesco l’Autorità competente voglia ordinare una riesumazione nel vero senso della parola, mentre in Militello vive e lavora il celebrato artista, che diede sì bella prova nel far rivivere il descritto quadro di S. Carlo Borromeo.”(1)
Dal 1912 fino al 1914, però, non c’è traccia di altra committenza pubblica. Sono comunque, quelli che vanno fino al 1916, gli anni in cui l’artista si fece conoscere, soprattutto a Palermo, dove espone in diverse occasioni. Resta traccia dell’attività di quel periodo in un articolo su una mostra collettiva, apparso nel 1916 sul “Giornale di Sicilia” di Palermo. Leggiamo testualmente:
“…Giuseppe Barone che con gusto veramente ammirevole rappresenta graziose scene paesane, profili campagnoli, leggiadre immagini di suonatrici e di fanciulle intente a ricamare merletti…”
Prevalevano, infatti, i quadri di piccola dimensione. Del ’12 sono un Viso di giovane donna(2), un Ragazze in chiesa(3) e un disegno, Monelli. Del ’13 il disegno Bimba e del ’14 l’olio Donne con scialle. Nel 1915 Barone dipinse alcuni piccoli gioielli, Vecchio marinaio(4), Piccola lavoratrice(5), Piccola suonatrice(6).
E finalmente arrivarono i grandi lavori. Ne resta testimonianza in un bozzetto per affresco, Natività(7), e nell’affresco con lo stesso titolo che si trova nella Chiesa Madre di Carlentini.
A Militello, poi, per la chiesa di San Nicolò cominciò a dipingere (gli ultimi due titoli sono datati 1916) il Ciclo di San Gerardo(8): Il miracolo di San Gerardo, L’ascensione di San Gerardo, La comunione di San Gerardo, La morte di San Gerardo.
Probabilmente, non mancarono neppure gli ordinativi di ritratti ufficiali, se in quel periodo possiamo collocare l’olio Ritratto della signora Zuccalà ed il Ritratto dell’arciprete Rivela(9). Il lavoro del pittore, in ogni caso, si svolse prevalentemente nella sua città, come testimoniano le opere datate che ci sono arrivate, tutte destinate a restare nella Chiesa Madre e nelle abitazioni private di Militello. Così, sono datati 1916 un disegno, Studio di fanciullo, un cartone per affresco, un altro Studio di fanciullo, ed un olio su tela con Due putti(10).
A seguire si possono citare due lavori del 1920, La nonna(11) e (forse) Testa(12); ed uno del 1921, Angeli in gloria(13).
L’anno successivo, il 27 dicembre del 1922, come risulta da un estratto dell’Atto di Matrimonio compilato dall’Ufficiale di Stato Civile, l’assessore delegato cav. Giuseppe Sciannaca, l’ormai trentacinquenne Barone sposò la ventitreenne Maria Rigon, nata e residente a Vicenza, di professione impiegata. A quel punto, l’artista aveva davvero bisogno di una committenza sufficientemente continuativa e non v’è alcun dubbio che quella che dava le garanzie migliori era la committenza religiosa.
Il 7 ottobre del 1923 nacque a Militello la prima figlia di Giuseppe Barone e probabilmente fu lei che gli ispirò il tenero disegno, Bimba dormiente(14). E finalmente si ebbe il trionfo della committenza pubblica (che, probabilmente, continuò pure l’anno successivo) con i ritratti di Francesco Laganà Campisi(15), di Pietro Carrera(16), di Vincenzo Natale(17), di Salvatore Majorana Calatabiano(18), di Angelo Majorana Calatabiano(19), di Giuseppe Musumeci Ristagno(20), oggi tutti nel Museo Civico. Datato 1924, così, resta soltanto una piccola opera, Mia madre(21).
Ma, per la riuscita professionale di Barone l’anno più importante del periodo giovanile risultò essere il 1925, quando ricevette l’incarico di affrescare la Cappella del Seminario di Siracusa. Splendidi particolari di tale lavoro furono San Matteo, Elia riceve il pane dal corvo e Mosè(22). Penso che il lavoro si protrasse fino al 1926, quando fra l’altro dipinse un Case e paesaggio(23), raffigurante il quartiere Bottazza di Militello, ora nel Museo Civico, e, per attendibile datazione, l’acquerello Mietitura(24) e l’olio Paesaggio di Militello(25).
Note
- Giuseppe Scirè, Cenni storici sulle chiese di Militello distrutte dal terremoto dell’11 gennaio 1693, per dichiarazione dell’autore opera ripresa dal manoscritto di don Sebastiano Gentile da Militello, canonico della collegiata di San Pietro e Paolo di Mineo (cfr. p. 98), Caltanissetta, Tipografia Ed. C. Riccioni, 1928, p.53;
- Olio su tela, cm. 22,5×28;
- Olio su tela, cm. 48×44;
- Olio su tavola, Militello, Museo Civico ”Sebastiano Guzzone”;
- Olio su tela, cm. 18×22, Archivio fotografico di A. Barone;
- Olio su tavola, cm. 26×21, Archivio fotografico di A. Barone;
- Olio su tavola, cm. 33×18, Archivio fotografico A. Barone;
- Oli su tela, Militello, Museo San Nicolò;
- Oggi nel Museo San Nicolò;
- Tutte opere che si conservano nel Museo San Nicolò;
- Olio su tela, cm. 44×64, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…;
- Olio su tavola, cm. 11,5×12,5, in Retrospettiva…;
- Tempera su cuoio, Militello, Museo San Nicolò;
- Disegno, in Retrospettiva…;
- Olio su tela, cm. 54×69, Militello, Museo”S. Guzzone”;
- Olio su tela, cm. 54×69, Militello, Museo “S. Guzzone”;
- Olio su tela, cm. 54×69, Militello, Museo “S. Guzzone”;
- Olio su tela, cm. 54×69, Militello, Museo “S. Guzzone”;
- Olio su masonite, cm. 50×60, Militello, Museo “S. Guzzone”;
- Olio su tela, cm. 5ox60, Militello, Museo “S. Guzzone”;
- Olio su tela, cm. 27×46, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…;
- Affreschi, Siracusa, Cappella del Seminario, Archivio fotografico di A. Barone;
- Olio, cm. 35×25, Militello, Museo civico “Sebastiano Guzzone”;
- Acquerello, cm. 17×18, in Retrospettiva…;
- Olio su tavola, in Retrospettiva…
4. Il contesto di Catania.
Nel 1927 il pittore militellese Giuseppe Barone si trasferì a Catania (anche se non cambiò contestualmente la residenza, dato che venne cancellato dal Registro della popolazione di Militello soltanto in data 1/10/1930(1).
Lì espose in diverse mostre organizzate dal “Circolo Artistico” e da altri enti. La città, fral’altro, insieme a Palermo e a Messina, in quel periodo viveva il suo clima avanguardistico.
L’esempio più esplicativo delle idee allora in circolazione era apparso circa dodici anni prima, il 10 aprile del 1915, sul periodico messinese “La balza futurista”. Si trattava di una poesia di Vann’Antò, Automobile + asina. L’opera dava il resoconto dei contraddittori itinerari culturali che c’erano in Sicilia: strisciate di vita attraversano la pagina; si vede una strada bianca, appena tracciata, sulla quale passano un’automobile spetezzante, una bicicletta drindrinante, un’asina ed un carro con le ruote che cigolano e s’inclinano sotto il carico; alla fine, però, l’asina si tira dietro, come in un funerale, l’automobile morta.
Rosa Maria Monastra vi ha visto “un vero e proprio rovesciamento dissimulato di alcuni precisi luoghi marinettiani.”(2) Io, che non possiedo i suoi occhiali, mi limito a registrarvi, per nulla dissimulato, il gusto della giustapposizione provocatoria e ironica degli irregolari, cosa, fra l’altro, che trovava le simpatie di Martinetti. Simpatie che, come ha scritto Luigi Tallarico, andavano pure agli irregolari “di sinistra, se vogliamo usare categorie estranee al futurismo e così, subito dopo, al fascismo.”(3)
L’automobile e l’asina, comunque, ripropongono almeno il dubbio di Alberto Asor Rosa davanti alla tentazione di definire il fascismo “come l’espressione di quella dialettica fra modernità, arieggiante all’industrialismo, e tradizione, imperniata essenzialmente sul ruralismo.”(4)
Infatti, a dispetto della suesposta teorizzazione, tale dialettica caratterizzò pure il precedente movimento liberty catanese, come sarà facile cogliere studiando l’opera pittorica, sempre “incontaminata”, rispetto alle “tendenze pittoriche più rivoluzionarie”(5), di Alessandro Abate (1867-1953). Essa presenta la vivacità dei colori, le pennellate umorali e le eleganze del nuovo contesto industrialista ed, al contempo, non rinuncia a soffermarsi sui temi della campagna, cosa che l’avvicina al gusto preraffaellita, “una specie di particolare espressionismo antelettera,”(6) che operò “una fiduciosa rivisitazione delle fonti pure, con le quali il rapporto è più di ricezione, di trepido ascolto, che non d’interlocuzione critica fondata sulla consapevolezza d’una rifondazione moderna del linguaggio.”(7)
Le decorazioni dell’Abate erano espressione di un sentire egemone e progressivo, dato che elegantirono nel 1907 la seconda esposizione agricola catanese, un momento di grandi progettazioni, quando si volle dare, come scrisse Federico De Roberto, “l’indice del risveglio agricolo ed industriale.”(8) Nella struttura che in occasione dell’esposizione fu realizzata (nell’attuale piazza Giovanni Verga) Abate pose il lavoro nei campi in una dimensione mitica ed al contempo industrialista, dato che:
“Superato l’ingresso principale disegnato dall’arcone arabo, entrando nel vestibolo, si poteva osservare nell’affresco della volta un altro vistoso compromesso, questa volta fra mitologiche deità pagane e contadini al lavoro nei campi, il tutto ben inquadrato in una cornice floreale vistosamente colorita.”(9)
Con l’avvento del fascismo, pur mantenendo lo stile liberty come ideale riferimento per il concetto d’eleganza, Abate rese molto più solide le forme della sua pittura. Ne è un esempio un bellissimo quadro oggi visibile nel salone di rappresentanza del Comune di Scordia. Una madre e il suo bambino stanno immersi in un aranceto fatto a immagine del paradiso. Tra il fogliame s’intravvedono gli elementi architettonici tipici della città. Di fronte a lei, visto di spalle, sta il marito con la zappa sulle spalle, ovviamente pronto al lavoro, a petto nudo, bronzeo e muscoloso. La donna ha la sensualità piena della nutrice, esaltata dal parallelo tra la rotondità del seno e quella delle arance (per le quali Scordia è rinomata). La scritta che campeggia nel quadro, “Comune di Scordia, 1933 –XI”, sovrastata dallo stemma della città, sembra scolpita col pennello di Sironi. Come si vede, l’opera, nata come manifesto pubblicitario, racchiude tutti i simboli cari all’ideologia ruralista che dominò l’Italia nel periodo fra le due guerre.
E, probabilmente, proprio in tale contraddittorio e fecondo crogiuolo va inquadrato il primo periodo catanese di Giuseppe Barone. Dopo le antiche rappresentazioni veriste ci fu un evidente gusto per la sinuosità delle linee, che rimanda a quella idealizzazione della materia – e, nel caso di figure femminili, alla chiara sensualità – presente, come s’è visto, nello stile dell’Abate. Fra l’altro, ci resta inconfutabile testimonianza di tale rimando culturale già nel 1927, con l’opera Primavera(10), che si lega concettualmente alla Decorazione con figure(11) ed a Diana con i compagni e paesaggio campestre(12), eseguite nel 1930 per un locale privato.
Di non minore interesse appare la figurazione ispirata al privato dell’artista: due disegni dedicati alla moglie ed uno, probabilmente, alla figlia(13). Di straordinaria intensità poetica, inoltre, sono gli oli (il primo dei quali sta nel Museo Civico) Ragazza al balcone(14), Strada di Militello(15), Sottoscala(16); e poi, nel 1930 Ciaramiddaru(17), nel 1931 Testina di bimba(18), Bimba dormiente(19), Mattino(20), Marina(21).
In ogni caso, le tante timidezze del contesto catanese nei confronti del moderno credo liberty furono testimoniate da diversi artisti coetanei, o quasi, di Giuseppe Barone. Ci fu, per esempio, Benedetto (o Nittu) Condorelli (1878-1950), che era stato in corrispondenza con Michele Cammarano(22) e propose una pittura densa e attenta al dato naturalistico. Non a caso egli in seguito costituì uno dei punti di riferimento della pittura sociale di Carmelo Comes, della quale quella dei grandi affreschi religiosi di Barone costituì un parallelo, forse meno impegnato nel dibattito politico, ma certamente più robusto nel disegno e più individualisticamente interessante.
Su una linea vicina a quella di Condorelli si collocò Francesco Mancini (1863-1948), coi suoi “en plein air” della campagna siciliana, dove, però, si evidenzia il gusto del piano ravvicinato, che permette di dare consistenza e nettezza di linee alle cose raffigurate.
Ci fu pure, con esiti qualche volta degni di menzione, al di là della sua stessa coscienza, Giuseppe Fichera (1896-1957), pittore di quel senso di intimità borghese dove, per dirla con Mario Mafai:
“A guardar bene c’è tanta arte da nutrire i più esigenti; ma per carità non sforziamoci di farla uscire da quei limiti, perderebbe la sua freschezza.”(23)
Degno di curiosità, invece, per la stranezza del percorso (e la non coincidenza con quello di Barone), è il caso di Vincenzo Marano (1890-1966), il quale:
“Per quanto legato alle tematiche tradizionali della pittura siciliana, con un buon accentuato gusto per le consonanze cromatiche e gli impianti naturalistici, sperimentò, negli anni ’50, la pittura astratta.”(24)
Vanno ancora ricordati Antonio Villani, che ebbe una grande influenza sui giovani artisti per le sue esperienze genovesi, Giuseppe Marletta (1892-?), Mario Siracusa (1890-?), Michele Torrisi Cacia (1881-1975), Rosario Pulvirenti (1899-1966), mentre particolarmente importante per la città di Militello fu lo scultore Mario Moschetti (1879-1960), che vi lasciò il Monumento al Milite Ignoto, posto all’entrata dei giardini pubblici, e un’Aquila in pietra bianca, che fa bellavista di sé sul muro laterale dell’attuale Farmacia Ciancio in piazza Vittorio Emanuele II. Egli, inoltre, fu autore di piccole sculture di teste infantili e di ritratti, sempre scultorei, di contemporanei celebri.
Note
- Cfr. Certificato di nascita di Giuseppe Barone rilasciato dal Comune di Militello in Val di Catania, Ufficio Anagrafe Popolazione.
- Rosa Maria Monastra, in “Cronache di una provincia”, 1/2/1980;
- Luigi Tallarico, Marinetti e l’ideologia politica del futurismo, in “Intervento”, nn. 88/89, gennaio-giugno 1989, Roma Giarrapico, p. 17;
- Alberto Asor Rosa, Selvaggismo e novecentismo, la cultura letteraria e artistica del regime, in AA. VV., Storia d’Italia, vol. IV (Dall’Unità ad oggi), tomo II (La cultura), Torino, Einaudi, 1975, p. 1500;
- S. N. (Salvatore Nicolosi), Abate, Alessandro, in Enciclopedia di Catania, diretta da Salvatore Nicolosi, Catania, Tringale, 1980, vol. I, p. 3;
- Domenico Purificato, La pittura dell’Ottocento italiano, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1959, p. 59;
- Antonio Del Guercio, La pittura dell’Ottocento, Torino, U.T.E.T., 1982, p. 152;
- In Esposizione di Catania, 1907, a cura di Federico De Roberto, Catania, Galatola, 1908, p. 10;
- Antonio Rocca, Il liberty a Catania, Catania, Magma, 1984, p. 18;
- Primavera – Decorazione con cinque figure, panno, vaso e fiori, olio su tela, cm. 47×70, Archivio fotografico A. Barone e in Retrospettiva…;
- 1930 – Decorazione con figure, tempera(?), esecuzione per locale privato, Archivio fotografico di A. Barone;
- 1930, autunno – Diana con i compagni e paesaggio campestre, tempera (?), esecuzione per locale privato(?), Archivio fotografico di A. Barone;
- 1927 – Vicenza n. 1, disegno, in Retrospettiva…; Vicenza n. 2, disegno, in Retrospettiva…; Testina di bimba n. 1, disegno, in Retrospettiva…;
- 1927 – Ragazza al balcone, olio su tela, Militello, Museo civico “Sebastiano Guzzone”;
- 1927 (?) – Strada di Militello, olio su tela, Retrospettiva…;
- 1928 – Sottoscala, olio, Archivio fotografico di A. Barone(2);
- 1930 – Ciaramiddaru, olio su tela, in Retrospettiva…;1931 – Testina di bimba n. 2, disegno, in Retrospettiva…;
- 1931 – Bimba dormiente, olio su tavola, cm. 20×20,5, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…;
- 1931 – Mattino, olio su tela, cm. 17×27, in Retrospettiva…;
- 1931 (?) – Marina, olio su tavola, cm. 36×32, in Retrospettiva…;
- Francesco Granata, Catania vecchia e nuova, Catania, Giannotta, 1973, pp. 141-146 e 147-148;
- Mario Mafai, Ottocento e Novecento, in “Fondaco”, n. 2, Catania 1927; cit. in Giuseppe Frazzetto, Solitari come nuvole, Catania, Maimone, 1988, p. 110;
- Giuseppe Frazzetto, Note degli artisti siciliani, in Una raccolta d’arte per Catania, catalogo della mostra, Catania, Accademia di Belle Arti, 22 aprile – 6 maggio 1985;
5. Nero dell’Etna.
Si può far risalire agli Anni Trenta la definitiva scelta d’arte (che fu pure scelta professionale) di Giuseppe Barone. Egli, infatti, divenne maestro nell’affresco e nella pittura monumentale, lasciandone ottimi saggi soprattutto negli edifici religiosi. Dal 1931 al 1934 dipinse per la Chiesa Madre di Nicolosi gli affreschi Sant’Antonio e La Pentecoste(1), oltre ai telieri Il cardinale Dusmet fra il popolo dopo la lava(2), L’orazione dell’orto(3) e Deposizione(4).
A differenza di quanto comunemente si crede, essa non fu frutto di una cultura attardata. L’affresco, infatti, grazie al contributo critico di Margherita Sarfatti, intellettuale di punta del fascismo ed amante di Mussolini, da alcuni anni era tornato a proporsi in contrasto (ma, sarebbe meglio dire “a fianco”) delle avanguardie novecentesche, tanto è vero che:
“La Biennale del 1924 è una delle più importanti nella storia della pittura italiana, se si pensa che vi comparvero, oltre ai due capolavori di Sironi L’allieva e L’architetto, che possono essere considerati concreti manifesti del gruppo novecentista, quadri come Meriggio di Casorati o In tram di Guidi… In tutti questi quadri il dettato plastico, tornito, a tempi lenti, si accompagnava a iconografie semplici, a tematiche solenni ed elementari, che si prestavano implicitamente alla riproposta ideologica di valori tradizionali… Il movimento sarebbe così divenuto, oltre che rappresentativo della scuola italiana, portavoce all’estero di una larga corrente dell’arte contemporanea… Comunque, la poetica di Sironi, intesa in senso largo nelle sue intenzioni celebrative e nel suo aspetto arcaicamente severo, caratterizzò le grandi imprese pittoriche degli anni Trenta, avendo come corrispettivo la scultura di Arturo Martini. Rientrano in questa atmosfera e proposito gli affreschi del Liviano a Padova (con preminenza questa volta di Campigli), il ciclo di Funi nel palazzo comunale di Ferrara – neoquattrocentista -, il mosaico di Severini sulla facciata del Palazzo dellePoste di Alessandria… A ben vedere, però, questo stile, sia come maniera espressiva sia come attitudine iconografica, perdurò nel dopoguerra in quanto specifico stile dell’arte d’occasione, specialmente gradito alla committenza religiosa: nell’Italia degli anni Cinquanta i postumi del novecentismo continuarono ad avere accoglienza e credito e si estinsero molto lentamente.”(5)
Questo perché già:
“Nel manifesto della pittura murale pubblicato nel 1933 su “La colonna” viene precisata la funzione sociale della grande pittura parietale e i legami con la tradizione che questa moderna concezione dell’arte comporta. I caratteri del moralismo sono collegati all’idea di una sintesi spirituale di cui tutta l’arte europea sente il bisogno per uscire dalla sterilità delle estetiche particolari e individuali.”(6)
Fra l’altro, in un’aura novecentista poteva collocarsi il più noto della schiera artistica catanese d’inizio secolo, Roberto Rimini (1888-1971), grazie al quale si può tranquillamente dimostrare quant’è nevrotica l’oscillazione dei giudizi critici.
Infatti, Rimini realizzò una serena rappresentazione del mondo rurale con un disegno classico, netto, che demarca i colori e chiude e potenzia le forme; particolare, quest’ultimo, che rende per lo meno opinabile il parallelo che venne operato tra lui e Giovanni Verga, dato che sul versante tecnico nello scrittore vi è qualche anticipo della deformazione espressionista.
Io, piuttosto, collocherei la pittura di Rimini accanto al vigore della poesia carducciana, coerente con gli intenti della poetica di Berto Ricci, direttore della prestigiosa rivista letteraria “L’Universale”. “Senza l’eloquenza” scrisse Ricci, “che porta seco la cosa, la grazia e la precisione nell’esprimersi, non c’è istinto poetico che tenga; e i sentimenti e i pensieri più belli restano nebbia vagabonda.”(7)
Con ciò possono, per esempio, spiegarsi alcuni esiti monumentalistici del Rimini, fatti che posero la sua opera in un itinerario anche fisicamente vicino a quello che veniva seguendo Giuseppe Barone. Destinato, infatti, a far mostra di sé accanto a un grande pannello di Barone raffigurante Il duce a cavallo(8), Rimini nel ’33 dipinse per il palazzo della borsa un altrettanto grande pannello “dedicato al lavoro nei campi, una delle attività italiche più celebrate dal regime.”(9)
Nel ’39, inoltre, Roberto Rimini decorò la fascistissima Casa del mutilato e forse per questo da morto è stato sottodimensionato. Così, se prima si leggeva “sembra che Rimini abbia avuto l’incarico di illuminare i quadri degli altri”(10), poi si leggerà “la pittura di Rimini rifugge dalla drammaticità, il riferimento al mondo dei vinti è in fondo esteriore, e l’insistervi rivela un’incomprensione – ma soprattutto il desiderio di individuare un interprete pittorico dell’immagine, insieme nostalgica ed arrogante, del primato della Sicilia rurale.”(11) Verrebbe da commentare che, per vecchio e tenace pregiudizio romantico, la conoscenza e l’osservanza delle regole viene considerata sinonimo di freddezza, o peggio attardamento tradizionalista. Come se alla base dell’universo e dell’arte (che è, in fondo, un universo parallelo creato dall’uomo) non ci sia sempre una logica, che in quanto tale si cristallizza in regole.
Così, volendo ripercorrere i grandi lavori eseguiti da Giuseppe Barone fino a tutto il 1941, dopo una veloce citazione di – Paesaggio etneo n. 1 del 1935 e Mucca nera del 1937(12), possiamo individuare nel 1934(?) La pietà, un cartone per affresco(13); sempre nel 1934 un’altra Pietà, affresco, per la città di Scicli, Cappella funeraria del Barone Penna; nel 1935 I due evangelisti Giovanni e Luca, affresco, per Misterbianco, Chiesa Madre, abside; nel 1936 L’Annunciazione, olio per la Chiesa Madre di Misterbianco, Cappella della Madonna; nel 1937 Otto figure sacre, affreschi, San Gregorio, Chiesa dei Salesiani, lunette; nel 1937 La fede, cartone per affresco con prove di colore per la chiesa di San Filippo Neri di Catania(12); nel 1937 La fede, affresco, Catania, Chiesa di San Filippo Neri, lunetta; nel 1937 La speranza, affresco, Catania, Chiesa di San Filippo Neri, lunetta; nel 1938 Sant’Antonio e Figura (cartoni per affresco oggi nel Museo Civico ”S. Guzzone”), l’affresco Martirio di Sant’Agata (per la chiesa catanese di San Biagio), gli oli Santa Elisabetta e Madonna (per la chiesa di Santa Maria di Gesù dei frati minori di Messina), oltre alla Crocifissione (olio su tavola, presente nell’Archiviofotografico di Agostino Barone); nel 1939 la tempera Beata MariaMazzarello (il cartone Angeli, oggi nel Museo “Guzzone”, riproduce un particolare), Sacro Cuore (olio, pala d’altare, Messina, Chiesa del SS. Salvatore), Pesce, vaso e limoni (1939?, olio, Archivio fotografico di A. Barone); nel 1940 Ragazza n. 1 (disegno, in Retrospettiva…); nel 1941 La Madonna della guardia – L’apparizione (olio, Misterbianco, fraz. di Borrello, Chiesa parrocchiale) e La lava che minacciò Borrello nel 1910 (Archivio fotografico di A. Barone).
Note
- 1931/1934 – Sant’Antonio – La Pentecoste, affreschi, Nicolosi, Chiesa Madre, cupola ed abside;
- 1934(?) – Il cardinale Dusmet fra il popolo dopo la lava, olio, quadro laterale, Nicolosi, Chiesa Madre, Cappella del Crocifisso;
- 1934 – L’orazione nell’orto, olio, quadro laterale, Nicolosi, ChiesaMadre, Cappella del Crocifisso;
- 1934 – Deposizione, olio, quadro laterale, Nicolosi, Chiesa Madre, Cappella del Crocifisso;
- Rossana Boscaglia, Sironi e il “Novecento”, Art e Dossier, Inserto redazionale allegato al n. 53, Firenze, Giunti, gennaio 1991, pp.13/20;
- AA. VV., Storia dell’arte italiana, diretta da Bertelli-Briganti-Giuliano, vol. IV, Milano, Electa-Bruno Mondatori, 1992, p. 471;
- Berto Ricci, Lo scrittore italiano, Roma, Ciarrapico, 1984, p. 53;
- 1936 (?) – La carta del lavoro, olio su tela, Catania, a suo tempo collocato nella sala del consiglio del palazzo dell’Economia Corporativa, ora palazzo della borsa – Camera di Commercio;
- Antonio Rocca, L’arte del ventennio a Catania, Catania, Magma, 1988, p. 171;
- Militello, Museo “S. Guzzone”;
- Vitaliano Brancati, Presentazione di una collettiva tenutasi a Catania nel 1937, cit. in S. N., Rimini Roberto, in Enciclopedia di Catania, op. cit., p. 241;
- Olio su tavola, cm. 40×40, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…;
- Giuseppe Frazzetto, Solitari come nuvole, op. cit., p. 105;
6. Gli anni intimisti.
E’ probabile che per Barone il1943 (l’anno dell’entrata degli anglo-americani e della fine della guerra in Sicilia) rappresentò un modo nuovo di concepire il suo operato artistico. Certamente continuò ad affrescare volte e pareti di chiese secondo l’ispirazione monumentalista di sempre; ma, a latere, come vedremo, non mancarono espressioni private: paesaggi e scene intime, dove si stendono certe velature di tristezza simili a quelle della metafisica di Giorgio Morandi. Come punto di svolta potrebbe essere assunto un disegno di quell’anno, Cavallo morto, dove la raffigurazione della povera carcassa diventa sconsolata denuncia del male della violenza.
D’altra parte, questa un’evoluzione fu condivisa con la generazione immediatamente più giovane della sua, quella nata all’inizio del secolo, che aveva dato vita alla seconda ondata futurista con Pippo Rizzo a Palermo e Mimì Lazzaro (1905-1958) a Catania; e soprattutto, insistendo nel parallelo con Barone, che aveva raggiunto esiti alti nel muralismo con Carmelo Comes (1905-1988) a Catania.
Come Barone, infatti, quest’ultimo nel corso degli anni Trenta aveva espresso una pittura che era andata “precisandosi in modo più personale, attraverso la pratica contemporanea di due differenti tematiche: da una parte una pittura di decisa impostazione socialisteggiante, anche se legata a stimoli novecentisti, dall’altra un’attenzione sempre più profonda verso il paesaggio”, questo perché “una grande nobiltà caratterizzava (…) i personaggi poveri, (…) fieri ed al tempo stesso dolenti della propria condizione.”(1)
Ovviamente, rispetto al significato del termine socialisteggiante, siamo davanti a una tesi, a dir poco, preconcetta. Tale aggettivo, a volerlo, lo si può generalizzare fino a comprendere tutte le opere dei populisti che videro “nel fascismo la rottura del conformismo borghese, la rinascita di uno spirito popolare selvaggio e aggressivo, di tradizioni italiane radicate nella terra e nel lavoro agricolo, in opposizione alla moderna civiltà laica europea: singolare espressione di questo orientamento è la rivista artistico-letteraria “Il selvaggio”, in cui circola uno spirito ribelle, scomposto e tuttavia autorizzato dal regime.”(2)
Sarebbe, invece, più fruttuoso inquadrare l’opera di Comes e di Barone nel sironiano intento di ottenere:
”Un’epica del quotidiano, un realismo metafisico, ovvero, alla lettera un surrealismo, esteso a riqualificare, quasi per un colpo di bacchetta magica, ogni aspetto della vita contemporanea. L’esito più adeguato di tale ambizioso programma sarà la realizzazione di imprese decorative parietali.”(3)
Gli affreschi e le grandi tele decorative di Comes (e di Barone), perciò:
“Ci sembrano gli episodi più intensi, i testimoni più attendibili della pittura e di una certa società dell’epoca.”(4)
Chiarito questo, diventa agevole seguire il filo logico dell’ultima produzione di Giuseppe Barone. Così, nel 1943 ci fu una Decorazione ad olio per la Chiesa del quartiere di Picanello a Catania; Cavallo morente (già citato disegno, di cui resta traccia nell’Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…); Militello n. 3 (olio su tavola, cm. 30×20, in Retrospettiva…); Militello n. 4 (olio su tavola, cm. 34×27, in Retrospettiva…); Campagna di Militello (olio su tavola, cm. 24×10, in Retrospettiva…). Nel 1944 dipinse Ragazza n. 2 (disegno); gli Affreschi nella volta per la Chiesa di Maria SS. Bambina a Catania nel quartiere di Ognuna; le Pale d’altare ad olio, sempre per la Chiesa di Maria SS. Bambina. Nel 1945 i Tre grandi affreschi nella volta per la Chiesa di Santa Maria della Stella di Militello; l’Annunciazione destinata alla volta di Santa Maria della Stella di Militello (cartone per affresco); l’Incoronazione della Vergine (bozzetto preparatorio); Fuga in Egitto (bozzetto preparatorio); Le tre doti di San Nicolò (bozzetto preparatorio); San Nicola (cartone per affresco); e, forse, la Vergine annunciata (cartone per affresco), San Giovanni evangelista (cartone per affresco destinato alla cupola di Santa Maria della Stella), il Discorso della montagna (che non fu mai realizzato) e l’Apoteosi (bozzetti preparatori dipinti su due facce).
Finita la guerra, nel 1946/1947 Barone realizzò: San Giovanni Bosco consegna la regola a Maria Mazzarello, olio, pala d’altare, per la Chiesa monumentale di San Polo di Palermo; e tra il 1946 ed il 1947 l’acquerello monocromo Chiesa di Santa Maria la Vetere, oggi a Militello nel Museo civico(5).
Nel 1947 ci furono San Nicolò (bozzetto preparatorio); Mosè e figure (cartone per affresco); Padre Eterno (cartone per affresco, Militello, Museo “San Nicolò”); Franca (olio su tela, cm. 45×60, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…). Nel 1947/48 gli affreschi Le tre doti, storia di San Nicolò e l’Apoteosi del Santissimo Salvatore, quest’ultimo dall’enorme lunghezza di dieci metri, per la Chiesa Madre di San Nicolò-SS. Salvatore di Militello. Nel 1948 Angeli(6)), cartone per affresco (Militello, Museo Civico); Affreschi nella volta della Chiesa Madre di Belpasso; le tele di Belpasso per Chiesa Madre, Cappella di Santa Lucia; Casetta, olio su tavola; e forse Maria Grazia, Natura morta n. 1, La casa rosa. Nel 1949 – Santa Lucia (probabilmente pensata per affrescare l’anno successivo l’omonima chiesa di Ognina a Catania), cartone per affresco, oggi a Militello nel Museo Civico.
Nel 1950 arrivarono Due affreschi nel transetto (Catania, quartiere di Ognina, Chiesa di Santa Lucia); Militello n. 5 (olio su tela, cm. 45×36, in Retrospettiva…); Mucche (olio su tela, cm. 36×43, Retrospettiva…); Mucca sdraiata (olio su tela, cm. 38×31, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…); Natura morta n. 2 (olio su tela, cm. 30×24, in Retrospettiva…); Margherite (olio su cartone, cm. 27×35, in Retrospettiva…); Natura morta n. 3 (olio su tavola, cm. 43×35, in Retrospettiva…). Nel 1951 Trasfigurazione o Gloria in cielo (bozzetto preparatorio, Militello, Museo San Nicolò). Nel 1952 Il reduce (olio su tavola, cm. 15×20, in Retrospettiva…); Ritratto (olio su cartone, in Retrospettiva…); Nella (olio su tela, Militello, Museo Civico); Autoritratto (olio su masonite, cm. 19×35,5, Militello, Museo Civico); Fiori e tavolozza (olio su cartone, cm. 33,5×28, in Retrospettiva…); Papaveri (olio su tela, cm. 22×31, in Retrospettiva…); Anemoni (olio su tela, in Retrospettiva…). Nel 1953 Luciana (olio su masonite, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva…). Nel 1954 Lettura (ritratto della moglie mentre legge sdraiata sul letto, olio, Archivio fotografico di A. Barone). Nel 1955 Autoritratto (disegno, Archivio fotografico di A. Barone); Autoritratto (olio su masonite, cm. 14×17, in Retrospettiva…); Paesaggio etneo n. 2 (olio su masonite, cm. 44×39, in Retrospettiva…); Paesaggio etneo n. 3 (olio su masonite, cm. 50×40, in Retrospettiva…); Paesaggio etneo n. 4 (olio su masonite, cm. 25×23, in Retrospettiva…); Paesaggio etneo n. 5 (olio su masonite, cm. 45×39, in Retrospettiva…); Chiesa del Borgo (olio su tela, cm. 44×39, in Retrospettiva…); Zafferana (olio su masonite, cm. 36×29, in Retrospettiva…); Carmela (olio su masonite, cm. 40×61, Archivio fotografico di A. Barone e in Retrospettiva); Ritratto di ragazza con cesto di frutta (olio, Archivio fotografico di A. Barone).
Nel 1956, infine, arrivò la morte. Poco tempo dopo fu organizzata una Retrospettiva in suo onore, poi venne l’immancabile velo d’oblio (spero squarciato in questa occasione, nella quale, fra l’altro, sotto la serie del n. 29, si ripropongono alcune inedite immagini).
Note
- Giuseppe Frazzetto, Arte a Catania 1921-1950, Catania, Pellicanolibri, 1984, p.40;
- Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana, vol. 4, Il Novecento, Torino, Einaudi, 1991, p. 74. Nel Museo Civico si trova una xilografia di Mino Maccari, che della rivista fu l’anima;
- Renato Barilli, L’arte contemporanea, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 227;
- Antonio Rocca, L’arte del ventennio a Catania, Catania, Magma, 1988, p. 72;
- Ecco un aneddoto sulla nascita di questo acquerello riferito da Enzo Maganuco in una testimonianza inserita in Retrospettiva…, cit.: “Molti anni fa, un ritratto virile a sanguigna, bene impostato e vivo nella sicura rappresentazione psicologica, in casa Fatuzzo a Vittoria, mi aveva colpito. Conobbi più tardi l’autore, Giuseppe Barone, a Militello, mentre facevo l’esplorazione sistematica di quella zona e grande fu la mia gioia quando quell’artista – che tale era col suo entusiasmo puro ed infantile e con la cordialità fresca degli onesti – vedendo il mio imbarazzo nella impossibilità di fotografare il protiro rinascimentale lauranesco nei pilastri gagginesco nella lunetta, della chiesa di Santa Maria la Vetere che la precinzione impediva all’obbiettivo di abbracciare tutto lo stupendo fastigio, mi volle offrire dopo due giorni di lavoro acutamente e gioiosamente vissuto per me, sol perché studiavo la sua terra, un grande acquerello monocromo disegnato magistralmente, che riproduceva l’opera.”
- Lo stile e la positura richiamano gli angeli dipinti nella pala d’altare San Giovanni Bosco consegna le regole a Maria Mazzarello del 1946 per la chiesa di San Polo aPalermo;
VI
SANTO MARINO E LA POETICA DELL’ IMPEGNO
1. Gli antecedenti catanesi.
Già negli anni Trenta a Catania la presenza artistica più intellettualmente vivace, la meno provinciale, quella di intelligenza più duttile ed aggiornata fu senza dubbio Mimì Maria Lazzaro (1905-1958). Martinetti lo definì “il più grande scultore che Sicilia abbia avuto.” Fu perlomeno lo scultore – ed il pittore – più irrequieto (insieme ai letterati G. Manzella Frontini, Giacomo Etna e Vitaliano Brancati), poiché per una peculiarità etnea, col futurismo espresse:
“Il desiderio di rigenerarsi dalla banalità volgare dell’Italietta umbertina attraverso una partecipazione attiva alla vita culturale e artistica del paese.”(1)
Dismessi gli iniziali furori futuristi, Lazzaro men che ventenne tenne un attivo dialogo col nucleo costitutivo della scuola romana, soprattutto con Mario Mafai e Gino Bonichi (detto Scipione). Così, nel 1929:
“Veniva nominato dal vertice romano del sindacato fascista di Belle Arti fiduciario del sindacato per la Sicilia orientale; mentre per la Sicilia occidentale era stato scelto Pippo Rizzo, amico della Sarfatti e attivo organizzatore, anche lui passato dal futurismo al Novecento.”(2)
Tutto ciò ci dà l’idea di un certo dinamismo interno al fascismo, trovandosi in esso inglobati anche movimenti tra loro molto diversi. Riguardo a Rizzo e a Lazzaro, per esempio, salta subito agli occhi l’arcaismo statuario del primo (secondo i canoni di Novecento) ed il surriscaldamento cromatico del secondo (secondo i canoni della Scuola Romana).
Comunque, la carica offrì a Lazzaro:
“La possibilità di ordinare mostre provinciali e regionali, spesso in accordo col segretario di Palermo, di presiedere commissioni giudicatrici, di ottenere o procurare ad altri pubbliche commesse, di partecipare alle grandi rassegne nazionali. Nacquero allora, nel corso degli anni Trenta, le statue in pietra del giardino Bellini di Catania, gli altorilievi bronzei del monumento al cardinale Dusmet, le teste di atleti in cemento nello stadio di Siracusa, la grande statua per la casa degli italiani a Parigi, l’altorilievo commemorativo de I Malavoglia ad Acitrezza, etc.”(3)
Al di là degli incarichi ufficiali, però, nella scultura e nella pittura di Lazzaro si espresse l’unicità di una personalità irrequieta, che indulgeva nei simboli (la statua L’adultera del ’35, attualmente nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, si racchiude nel gesto dell’anello nuziale sfilato dal dito), nelle temperature cromatiche estreme (I ciclopi del ’32 è tutto giocato su freddissimi azzurri, mentre Fornace dello stesso anno è un’escalation di gialli e rossi), nel cogliere l’istante che meglio esprime il movimento (Vergine che si desta del ’33, ora all’Ist. Stat. d’Arte di Palermo; Vergine tamburina del ’34, esposta alla XIX° Biennale di Venezia; Incantesimo e Colapesce ambedue del ’38).
Anche se non del tutto inquadrabili nello stesso contesto di Lazzaro, meritano, poi, attenzione Giovanni Alicò (1906-1957), autore di oneste e pulite stesure di colore; Antonio Barbera (1908-1934), disegnatore dal tratto lieve; Archimede Cirinnà (1908-?); Sebastiano Formica (1912-1932), calatino allievo di Corona, morto annegato nell’Arno, a cui fu dedicata una Retrospettiva nella IV mostra sindacale del ’33, autore apprezzabile soprattutto per i disegni, che hanno un forte addensarsi di scuri sapientemente distribuiti (egli, fra l’altro, qualche anno fa ha ispirato un bel racconto dello scrittore calatino Daniele Sortino); Rosario Frazzetto (1913-1980), la cui scultura con le sue forme piene ripropose la ricerca di modelli archetipici; Salvo Giordano (1909-?), scultore capace di cogliere il gesto come in un’istantanea e di trasmetterci una sensualità pacata, da interno familiare; Pippo Giuffrida (1912-1977); Gemma D’Amico (1906-1980); Gaetano Longo (1915-?); Carmelo Molino (1908-1984); Nino Nicolosi Scandurra (1913-1983); Ildebrando Patamia (1905-?); Francesco Ranno (1907-?); Eugenio Russo (1910-?); Francesco Schilirò (1913-1942), che veniva dalla pittura di carretti; Filippo Sgarlata (1901-1979), che ripropose modi scultorei del Quattrocento; Guglielmo Volpe (1910-?), autore del busto di Salvatore Majorana posto nel Municipio di Militello. Una particolare menzione merita, infine, Carmelo Mendola (1895-1976), autore di un perduto busto di Sebastiano Guzzone che era posto nel Giardini Pubblici di Militello (di recente, però, ho avuto notizia del Bozzetto in gesso di quest’opera, attualmente proprietà degli eredi Mendola). Scultore autodidatta, egli dagli iniziali “volumi chiusi e levigati” seppe arrivare:
“Agli slanci di svolgimenti articolati in ritmi di calcolata dinamica.”(4)
Biograficamente non lontanissimo da Comes e da Lazzaro, Elio Romano (n. 1909) a più giusto titolo va collocato nel dibattito culturale del secondo dopoguerra novecentesco, tematicamente e stilisticamente già vicino a Renato Guttuso e al militellese Santo Marino. Egli, infatti, tenne la prima personale nel 1947, al Circolo artistico di Catania(5).
Eppure, i suoi lavori del periodo fra le due guerre hanno un’ammirevole specificità, per la scrupolosa attenzione al colore come materia da costruire con impasti complessi e terragni, valorizzati dal disegno semplice, che ben s’accordano con la quotidianità dei soggetti. Non hanno dramma, ma neppure oleografia. Realizzano piuttosto il disgelarsi di una dolce bellezza, posseduta senza conoscerla, sempre guardata e mai vista.
Il neorealismo vero e proprio cominciò con Saro Mirabella (1914-1972), uno dei primi riferimenti di Santo Marino, che espresse un’accesa (e qualche volta scomposta) pietatem verso il mondo degli umili, per cui, quasi per un obbligo, operò la scelta espressionista.
Meno urlati appaiono i lavori di Sebastiano Milluzzo (n. 1915) e di Nunzio Sciavarrello (n. 1918). Essi(6) hanno posto nella poesia lo specifico della pittura: per i soggetti (i clown di Milluzzo, i pupi di Sciavarrello), per certo vibrare della linea sottile del disegno (Sciavarrello) e dei colori, spesso chiari e calibrati per dare il senso di una piena e serena eleganza (Sciavarrello e Milluzzo).
Qui ci si può fermare, volendo trascurare le figure di Emilio Greco e di Francesco Messina, i quali, date le dimensioni, più che artisti catanesi sono artisti italiani nati nel Catanese, per cui con essi sarebbe d’obbligo ripartire negli studi da zero.
Note
- Rita Verderame, Giacomo Etna nella cultura siciliana tra il Venti ed il Cinquanta, in AA. VV., Vincenzo Musco(Giacomo Etna) – I pittori niscemesi contemporanei, Niscemi, Comune di Niscemi, 1986, p. 30;
- Franco Grasso, M. M. Lazzaro, supplemento al n. 5, anno III, di “Kalos”, Edizioni Ariete, Palermo, settembre-ottobre 1991, p. 13;
- Franco Grasso, ibidem;
- Giuseppe Consoli, Il Cellini dell’acqua, in “La Sicilia”, Catania, del 27/2/1986;
- Vedi Francesco Gallo, Elio Romano, Catania, Comune di Catania, 1983. Ed Elio Romano, a cura di Virgilio Inastasi, Milano, Mazzotta, 1986;
- Per Mirabella, Milluzzo e Sciavarrello sono stati utilmente consultati Sicilia arte 2, suppl. al n. 3 di “Cronache parlamentari siciliane”, aprile 1989. E Siciliana, a cura di Francesco Gallo, Milano, Mazzotta, 1986.
2. Santo Marino, dal neorealismo agli incantamenti della realtà.
Quando Santo Marino (nato nel 1924) lasciò la natia Militello per frequentare il liceo artistico di Palermo, dove si diplomò nel 1947, nell’arte e nella cultura italiana ferveva l’impegno politico. Al Nord negli ultimi due anni di guerra c’era stata la lotta partigiana ed al Sud l’immediato dopoguerra era agitato dalle rivendicazioni contadine. Il cinema e la letteratura rispecchiavano tutto ciò con la grande stagione del neorealismo. Visconti, Rossellini, De Sica, De Santis sullo schermo e nella scrittura Quasimodo, Fenoglio, Pavese e Vittorini condividevano e realizzavano i propositi della lettera-testamento di Giaime Pintor, scritta poco prima di cadere da antifascista:
“Ad un certo momento” vi si leggeva, “gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell’utilità comune, ciascuno deve sapere prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento… Musicisti e scrittori, dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti”(1).
Nella figurazione Renato Guttuso ed i suoi sodali di Corrente avevano intrapreso un percorso parallelo. Lasciati i narcisistici e solipsisistici contorcimenti di molta avanguardia, , essi volevano porre l’evidenza dei drammi collettivi. Come nel Quasimodo della “poesia corale”, il pronome “io” era stato sostituito dal ben più generoso e più severo “noi”.
La visione non edulcorata della realtà pretendeva, però, il superamento della rappresentazione meramente pellicolare. Così, una prestigiosa schiera di artisti (Guttuso in testa; ma pure Levi, Migneco, Treccani e tanti altri), oltre a riproporre il figurativismo, riecheggiarono l’espressionismo tedesco, che con la sapiente alterazione delle linee e dei colori aveva dato l’esempio di una tecnica da cui risulta esplicita la posizione politica. Si pensi al repellente Generale di George Gorsz, oggi alla Gallerie Claude Bernard di Parigi (e si faccia il paragone coi Generali dipinti da Santo Marino per una sua mostra tenutasi a Militello nei primi anni Settanta); oppure al lancinante patetismo di Trincea nelle Fiandre di Otto Dix, conservata nel Preussischer Staatliche Museum di Berlino.
Era, quindi, naturale che Santo Marino, meridionale e figlio di contadino, concepisse l’arte come un’arma di lotta e di riscatto, accostandosi fin dagli esordi ai moduli tecnici dell’espressionismo mediterraneo.
“Il problema” disse in un’intervista del 1987, ma avrebbe potuto dirlo anche quarant’anni prima, “per me come per ogni altro artista, è solo quello di conoscere; e certo conoscere è trasformare.”
Fu questo il presupposto per cui l’attività espositiva finì spesso per coincidere con la militanza politica. Anche nei riscontri in termini di successo e di esposizioni ufficiali.
Nel 1959, infatti, Marino fu a Vienna per partecipare alla mostra internazionale “Giovane Pittura Italiana”. Nel 1964, su invito del governo della Germania comunista, tenne una personale di sessanta disegni a Berlino e nello stesso anno espose a Dresda. Nel 1965 tornò in Germania per partecipare all’”Intergrafik 65” di Berlino ed alla mostra internazionale di grafica di Leipzg. Nelle numerose mostre italiane ed estere che tenne potè, inoltre, contare, sui contributi critici di molti intellettuali cari alla Sinistra, quali Leonardo Sciascia, Santo Calì, Giuseppe Bonaviri, Gabriele Mucchi, Franco Solmi, Mario Lepore e David Alfaro Siquerios.
Bisogna dire, però, che egli (forse proprio per queste frequentazioni) si allontanò raramente dai personaggi, dalle case e dalla campagna della sua piccola Militello.
“Anche quando dipingo una mosca” affermò, “voglio che sia una mosca militellese.”
Volle, perciò, proporre una sicilianità non banale, nel senso che il suo concetto di appartenenza alla terra d’origine era molto vicino alla sicilitudine definita da Leonardo Sciascia (che, a sua volta, l’aveva mutuato dalla francese “negritude”, parola con la quale Jean Paul Sartre, parlando dei poeti africani, indicava un’idea più profonda del “colore locale”, ch’era la loro particolare predisposizione d’animo; o, meglio ancora, il loro particolare modo d’interpretare il mondo).
L’itinerario artistico di Santo Marino, quindi, cominciò con certe figure di contadini, che (superando la rabbia del Guttuso più propagandistico) volevano trasmettere soprattutto un’idea di gravità, di virilità e di umanità capace di dominare sulla sofferenza.
Con gli occhi, soprattutto. Negli sguardi di questi uomini leggiamo lo sbigottimento ed il sogno. Guardano e sono guardati pensando che l’ingiustizia può essere battuta mostrandone le vittime. C’è in ciò un ottimismo storico di fondo, perché conseguentemente il progresso vien visto come uno svolgersi ineluttabile, al di là di tutte le momentanee contraddizioni. Si potrebbe quasi dire che l’ottimismo di Marino, per sua stessa ammissione, fu un ottimismo cristiano.
Anche se il precedente a lui più congeniale fu il pessimista Giovanni Verga, come venne giustamente messo in evidenza da Leonardo Sciascia (2). Qui aggiungerò che il nesso fra i due si coglie pure nel titanismo dei personaggi rappresentati. Il disegno fortemente inciso e le cromie sature, infatti, comunicano l’energia di una volontà forte, come se l’antica fame del Sud, finalmente, avesse generato i suoi eroi. E proprio perché si tratta di eroi, questi “giganti siciliani” sono molto meno “guttusiani” di quanto di solito non si pensi. Essi sono dei solitari. Non si confondono mai nella massa, seppur rivoluzionaria.
Anche quando dipinse la natura, Marino in qualche modo alfiereggiò. Si guardi, per capirlo, il catalogo delle opere esposte nelle mostre Antologia del mare e Omaggio a David Alfaro Siquerios, tenutesi ambedue negli anni settanta, presso la galleria “Cavallotto” di Catania. Con sintesi audaci, che non disdegnarono di risolversi in volute astratte ed eleganti, egli tentò di cogliere l’anima individualista dei paesaggi, il loro primo palpito e la vita.
Il suo vitalismo non gli impedì, d’altra parte, momenti teneri quando dipinse i bambini, o gli innamorati, od il candido vibrare delle ali di una colomba. E probabilmente in questi va cercata la continuità stilistica con le opere dipinte dopo la crisi ideologica, culminata, sempre negli anni settanta e sempre presso la “Cavallotto”, nella mostra L’uomo, la natura, la violenza.
Negli ultimi anni, così, i suoi paesaggi acquistarono un’intensità cromatica, da cui traspariva un “furor elegantis iudicii” sempre più accentuato. Il mare, gli ulivi, i fichidindia, i limoni, le spighe di grano, le fughe di tegole sui tetti, gli umili arredi delle dimore contadine, le balaustrate di ferro battuto e tutta l’inesauribile ricchezza di figurazioni siciliane furono portati in una dimensione magica, forse per gli echi che in lui lasciò la lettura di Cien anos de soledad di Gabriel Garcìa Màrquez.
Le opere di questo periodo (anni ottanta), pur di prodigiosa esuberanza, denunciano un mestiere ormai acquisito, mantenendosi sempre alto il loro effetto d’impatto, anche quando l’ispirazione risultò stanca.
Mori nel 1991, travolto da un treno, mentre attraversava distratto un passaggio a livello incustodito, forse perduto ad inseguire le immagini del suo prossimo dipinto, andando nella sua casa di campagna (figg. 30 a seguire).
Note
- In Giuliano Manacorda, Storia della letteratura italiana contemporanea (1940-1965), Roma, Editori Riuniti, 1974, pp. 3-4;
- cfr. Leonardo Sciascia, Santo Marino, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1963.
3. Santo Marino e la sicilitudine.
La scrittura per suggestioni parallele di Leonardo Sciascia potrebbe assumersi come esempio di rovesciamento delle correnti posizioni critiche. Al suo riguardo, infatti, sarà difficile per ogni ipotetico futuro storico della letteratura cavarsela in poche righe. O troppo facile, se voglionsi prendere per buone le approssimazioni fuorvianti, tipo “scrittore illuminista”, che riempirono i giornali all’indomani della sua morte.
Degna, fra le poche, poiché ben costruita, l’approssimazione di Giuseppe Pontiggia: “La differenza da Pirandello è che non accetta l’ineluttabilità della condizione umana, ma ne ricerca le premesse, e una possibilità di riscatto, nella storia.”
Resta, illuministicamente, scrittore dell’investigazione, Leonardo Sciascia, fondamentalmente ottimista sulle possibilità di conoscenza, e perciò di miglioramento sociale, pur con:
“Una prospettiva visionaria, che si fonde con le altre imprimendovi il suo suggello”(1).
Ora, volendo indagare fuori dagli usati sentieri, ci si può riferire ad uno Sciascia inespolorato, minore senz’altro, ma pure immediato e meglio decodificabile, scrittore, si direbbe con Renato Barilli, di “quel genere affatto particolare nel settore delle arti visive che è la presentazione in catalogo, ove il critico assume la veste retorica del patrocinatore, dell’avvocato di difesa”(2).
Una cosa pare subito evidente. Sciascia, da maestro, patrocina in via indiretta. Fluisce, il più delle volte, un discorrere parallelo, magari lontano nel tempo e nello spazio, pieno di rapide, di insenature, di calmi slargarsi.
Ne è già pieno esempio il saggio Santo Marino, uscito nel 1963, per le Edizioni Salvatore Sciascia, sessantesimo dei quaderni di “Galleria”, di quel genere, se non il primo, uno dei primi.
La partenza è bella. Intrigante, si direbbe oggi. Il rapporto fra uno scrittore ed un artista, quello fra Manzoni e Gonin, per esempio, scrive Sciascia, ha misteri che vanno ben oltre le scontate gerarchie (che vedrebbero il secondo quale illustratore del primo). Trattasi, forse, di affinità dei modelli di vita, o, forse, diciamo noi, di plutarchiani parallelismi.
La categoria della solitudine, sul filo delle su esposte considerazioni, potrebbe, quindi, essere una chiave per capire la scrittura del Verga e la pittura del Marino (che del Verga sarebbe ottimo illustratore). E, quindi, per arrivare alla definizione di una situazione dell’essere tipica della Sicilia, cioè di quel concetto che potremmo chiamare sicilitudine (come in effetti in altra sedelo chiamò Sciascia stesso).
A Militello, poi, il paese del pittore Marino, vi è una delle più alte raffigurazioni della solitudine, il Ritratto di Piero Speciale di Francesco Laurana (anche se va detto che l’opera a cui si riferiva Sciascia da altri è stata attribuita a Domenico Gaggini). Solitudine ed anelito all’impegno nel sociale, dualismo di gran parte della cultura siciliana (e contadina, si dovrebbe aggiungere. Si pensi a Pavese, al suo titanismo chiuso, al suo ingenuo alfierismo neo-realista).
Il saggio non contiene una sola notazione tecnica, non sulle caratteristiche della pittura, non sul contesto figurativo (o, meglio, questo compare genericamente, si direbbe qualunquisticamente). E’, nella sostanza, un’opera molto sciasciana. A prima vista, un’indagine, un ricercare fra le pieghe stavolta non della storia, ma di una rappresentazione artistica. Più giusto parrebbe, però, definirlo una suggestione parallela.
Sciascia, qui e nel resto della sua opera, non esplica una vera e propria queste, una medioevalistica ricerca del senso delle cose. Segue un filo capriccioso, dagli accostamenti barocchi. I fatti diventano un giuoco pirandelliano, o borgesiano, di specchi multipli, in cui moltiplicare se stesso. Non c’è il culto illuminista della ragione, ma la furbizia di una personalissima poetica.
Lo conferma uno scritto successivo, dal carattere più scopertamente da critico d’arte; anzi, da talent scout dell’arte. E’ la presentazione in catalogo di un allora giovane pittore, Giuseppe Tuccio, notevole pei suoi lirici ritratti di bambini. E’ datato 20-2/5-3 1966, per le edizioni della Galleria di Vito Cavallotto di Caltanissetta.
Sebbene Sciascia si sbilanci in un giudizio netto – “il suo è un autentico e grande talento” -, il pezzo resta un perfetto esempio di letterarietà. Lo scrittore, del suo incontro con Tuccio, fa un bellissimo apologo della “carenza e fortuità degli incontri culturali in Sicilia”. Il che sarebbe un altro modo di definire la categoria della solitudine.
Successivamente, Sciascia ripresenta Tuccio alla Galleria d’arte “La Tavolazza” di Palermo e ne trae il ritratto di un siciliano taciturno (di solito, i migliori, sosterrà in La scomparsa di Majorana). Forse, trattasi dell’indagine di un’anima, forse, più semplicemente, della costruzione di un modello letterario.
Nel 1970 lo scrittore pubblica Maccari alla “Tavolozza” per le edizioni della galleria. Sarebbe meglio dire che ne riscrive il mondo, accostando ricordi d’infanzia, suggestioni letterarie (Dos Passos, i Goncourt, Bayle), La vedova allegra di Lehar ed i quadri di Lautrec. Egli, ancora una volta, con gli accostamenti più liberi, che si direbbero geniali spunti di recherche, non fa altro che seguire una strada che con la pittura del Maccari non si incontra, anche se le corre accanto. Non è, ciò, una diminuzione della validità, ma una ricollocazione dello scritto nella letterarietà. Al fondo, come in tutta la sua restante opera, non c’è la discesa dell’analisi, c’è l’elevarsi della creazione.
Un anno dopo, per la I.R.E.S. di Palermo Sciascia scrive La semplificazione delle forme, presentazione del pittore Renato Guttuso. Ancora, per spiegare un’arte di così particolare tecnica, come la pittura, viene individuato un letterarissimo concetto unificante, la crisi.
“La pittura di Guttuso (…) è tutta nell’ossessiva premonizione o presenze di mostri” conchiude il Nostro, dopo il solito farfalleggiante sovrapporsi di letture disparate e di concetti originali.
Uno particolarmente pregnante:
“Un grande artista, un grande scrittore, non ha ironia e non ha gusto; e così anche i grandi movimenti della letteratura, dell’arte, sono quelli che mancano di gusto e non sono governati dall’ironia.”
Innegabilmente, Sciascia, con questi lampeggiamenti, che sono l’esatto contrario di una deduzione logica, par che sia riuscito a centrare il suo argomento meglio dei troppi collezionisti di francobolli travestiti da critici d’arte, che infestano le patrie accademie.
Ma, in questa sede importa notare, soprattutto, la libertà (anzi, la geniale arbitrarietà) delle costruzioni di argomenti dello scrittore. Il che ci permette di collocarlo in quella coda del decadentismo, che, da Pirandello a Borges, attraversa il nostro secolo. I tempi non sono eroici, l’omologazione impera. L’artista non è più il cantore di un sentire collettivo (eppure, Guttuso, programmaticamente, voleva esserlo).
Resta soltanto la denuncia, la crisi, il sentimento speculare a quello di Sciascia. O, un’insoddisfatta nostalgia.
Per esempio, per il lussureggiante fiorire di vita, sapori e colori nel quadro La Vucciria dello stesso Guttuso(3). Dove, però, vi è una malinconica coscienza dell’idea di morte insista nel materialismo siciliano, che riporta alle migliori pagine di Feste religiose in Sicilia.
Nel 1971, per le Edizioni “Il Gigno” di Roma, esce il saggio Emilio Greco. E’ tutto risolto in chiave brancatiana. La donna è madre e frutto del sogno dei siciliani, è un perfetto e finito universo creativo. Greco richiama i personaggi di Brancati, che ricreano nell’aria accensioni di eros. Quindi, dallo scultore si arriva alla rappresentazione corale d’un mondo unidimensionale, come lo pensa e lo crea l’io dello scrittore.
E, finalmente, ultimo della serie qui presa in considerazione, nel 1972, edito da La Nuova Pesa di Roma, c’è una presentazione in catalogo di Bruno Caruso, dove la minuziosità antonelliana del disegno dell’artista è per Sciascia motivo d’enigma, “inverno di cose ed eventi che si specchiano”.
Ritorna il gusto borgesiano del deragliamento; anzi, quello sciasciano del mostrare l’altra faccia della storia. Quella storia che, dice in un’intervista apparsa sulla rivista catanese “Carte Siciliane”:
“Non è maestra di vita, come una volta si diceva. E’ assurda come la vita.”(4)
Dalla storia, dalla società – o, con la storia e con la società – Sciascia, infatti, si tira fuori. Contesta. Si batte, seppure rassegnato a perdere. E’ l’isolato ribelle decadente, nella nottata di questo secolo, tanto lunga da passare.
Note
- Giuseppe Pontiggia, in “Corriere della sera”, Milano, 21/11/89;
- Renato Barilli, Informale oggetto comportamento, Milano, Feltrinelli, vol. 1, p.5;
- Leonardo Sciascia, in “Sicilia”, n.76, Palermo, Flaccovio, 1975;
- “Carte siciliane”, n. 1, Catania, luglio-settembre 1985.
4. L’immaginario popolare.
Sul versante della decorazione novecentesca, oltre al decoratore di carretti don Ramunnu, credo che sia da riscoprire l’opera dello scultore Mariano Zuccalà (1880?-1935), che iniziò gli studi artistici nel 1892 a Catania, nella cerchia del prof. Carlo Garuglieri. Si distinse per un bassorilievo in pastellina esposto al Reale Ospizio di Beneficenza di Torino. Eseguì decorazioni nei cantieri dell’industriale Marco Patriarca ed in chiese, palazzi, caffè, cinema (si ricorda la Sala Roma a Catania). Fu autore, inoltre, di complesse costruzioni plastiche, quali Ilpresepio, Ilriposo, Lacena, dove una tecnica non perfettissima viene riscattata dai pregi di un racconto ingenuo, non privo di note spiritose (nel Presepio, per esempio, egli inserisce sé stesso, ritraendosi con l’eterna pipa in bocca mentre da una finestra guarda la scena sacra). A Militello di lui restano diversi Capezzali in gesso e le decorazioni delle scale interne di Palazzo Baldanza.
Una veloce citazione merita pure Nicolò Sinatra, già ricordato come fotografo ed autore di cartoline, per i suoi dipinti di paesaggio che, seppur banali nei temi e nelle stesure cromatiche, evidenziano un’onesta fatica per arrivare almeno alla correttezza del disegno.
Cantastorie dal forte impegno politico, invece, può definirsi il vivente Franco Tringale. La miscela di arte e politica appare meglio rappresentata a partire dagli anni settanta, quando l’egemonia culturale della Sinistra, fra mille cose pessime, ebbe il merito di determinare una congerie di documenti che, nati ideologici, furono capaci di diventare testimonianze umane. Il fenomeno riguardò, più o meno, l’Italia intera. Infatti, una schiera di artisti interessante risultò quella dei cantautori. Di questi, Paolo Pietrangeli ed Ivan Della Mea forse riuscirono ad avere i migliori esiti poetici. Canzoni come Contessa (di Pietrangeli) o O cara moglie (di Della Mea) suscitano tuttora fremiti di commozione, pur nella loro inesorabile datazione.
Ma, rare volte, credo, studiando il corpus musicale, poetico e pittorico di un autore, si ha una vera e propria immagine speculare della vulgata corrente, come quando si analizza la produzione di un cantastorie. Nel caso di Tringale, in particolare, in coerenza con l’odierna epoca, trattasi di luoghi comuni progressisti.
Egli ebbe il primo successo con La tragedia dei Kennedy, con la quale nel 1968 vinse la Sagra dei cantastorie di Piacenza. Resta uno dei suoi lavori migliori, dove ci sono tutte le caratteristiche di un genere popolare e semplificatorio. Così, il mondo viene guardato con manicheismo. Tutto è semplice: i buoni stanno da una parte ed i cattivi dall’altra. C’è pure un macroscopico falso storico Infatti, Tringale invita gli americani ad andar via dal Vietnam, dimenticando che fu proprio il buon Kennedy a volere quella guerra. Ma, a parte le idee, il testo ha una sua nobiltà, datagli da una tradizione secolare. Va ascoltato con simpatia, ma senza prenderlo sul serio, come si ascoltano le storie di Orlando e Rinaldo, o di cumpari Turiddu e donna Lola.
Le suddette caratteristiche si accentuano nella sterminata produzione successiva, dove l’impegno politico del cantastorie è aumentato, portando sui palcoscenici i temi delle lotte comuniste, rispecchiando una cronaca troppo spesso inattendibile (quanto veniva detto sulle stragi, sull’occupazione e sulla condizione operaia).
Un giorno, però, per scelta di campo estremista ruppe col PCI e così la sua carriera ebbe un brusco arresto. Era arrivato il momento del ritorno all’ordine. Non ne guadagnò, purtroppo, l’ispirazione. I testi che produsse non vanno al di là del luogo comune ed anche l’ironia s’incanaglisce nel sarcasmo.
Meritano, comunque, d’essere citate Lettera alla moglie, Lo stagionale, Battaglia del 9 aprile. Qualche gusto, infine, mi viene dal riportare alcuni versi suoi che “dal punto di vista politico” non convinsero il famoso dirigente comunista Giancarlo Paietta:
Per ogni Coca Cola che tu bevi
Un proiettile all’America hai pagato
E, se il marine la mira non fallisce,
Un compagno vietnamita assassinato!Dalla Natività di Andrea Della Robbia ai Contadini di Santo Marino (Storia dell’Arte a Militello nel Valle di Catania)Biblioteca comunale di Militello in Val di Catania

